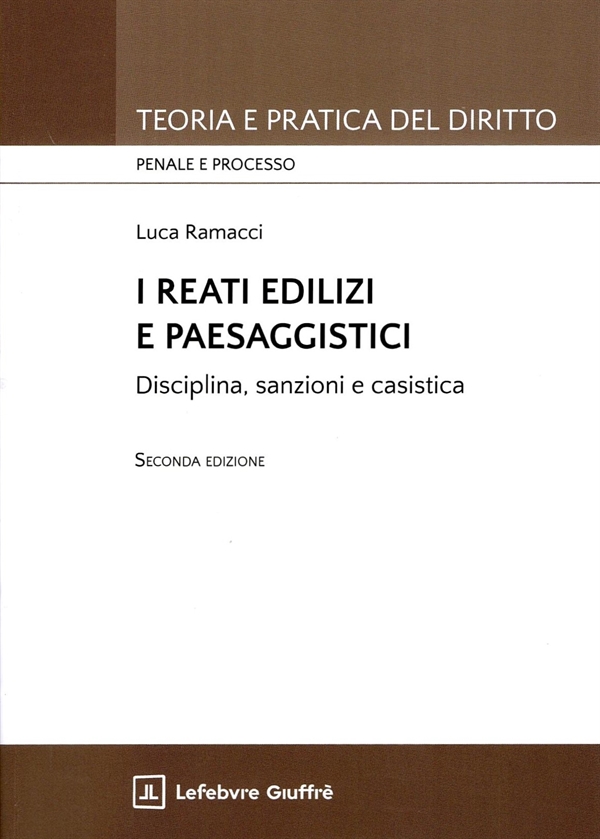SOMMARIO
Introduzione pag. 2
La depenalizzazione pag. 3
Gli scarichi esistenti pag. 5
Il nuovo articolo 56 pag. 6
La
mancata osservazione delle prescrizioni indicate
nel provvedimento di autorizzazione pag. 7
L’immissione occasionale pag. 8
L’articolo 58 pag. 11
Il gestore degli impianti pag. 12
Nuove sanzioni amministrative e penali pag. 13
Il campionamento pag. 17
Gli articoli 56, 57, 58, 59 del vecchio e nuovo
D. Lgs. 152/1999 pag. 20
Bibliografia pag. 28
· Introduzione
Nel 1976, con l’emanazione della Legge n. 319 cosiddetta “Legge Merli” (Norme per la tutela delle acque inquinate), l’Italia fece un ulteriore passo nel riconoscere, a livello nazionale, l’ambiente come oggetto di tutela.
Anche
se né allora né adesso risulta esserci una definizione legislativa di
ambiente, tendenzialmente si iniziò ad individuare in tale concetto quegli
elementi principali, ma non solo, e necessari alla presenza della vita, in
altre parole terra, aria, acqua.
Subito
ci si dovette scontrare col problema, di non facile soluzione, di dover porre
dei limiti quantitativi alla presenza di sostanze non salutari agli esseri
viventi in un elemento naturale quale la terra, l’aria o l’acqua, per
poter definire tale elemento inquinato o meno.
Ciò
rappresentò e rappresenta ancor oggi un problema di notevole entità per il
semplice fatto che è, e sempre sarà, una imposizione dettata da menti umane
più o meno capaci e coscienziose a definire fino a quando, a che
livello un elemento può definirsi non inquinato o inquinato e quindi dannoso.
Tale limite sarà sempre frutto di valutazioni più che altro soggettive.
Comunque,
come per ogni legge o altro provvedimento legislativo che impone dei limiti da
rispettare, anche la Legge Merli prevedeva un sistema sanzionatorio
amministrativo e penale da applicare alla persona, sia fisica, sia giuridica,
che non rispettava e/o dimostrava di non voler rispettare tali obblighi.
Per
i successivi vent’anni tale legge fu parecchio commentata ed interpretata,
anche mediante interventi da parte della Cassazione.
Una
svolta a livello normativo la si ottenne solo negli ultimi anni attraverso la
pubblicazione del D. Lgs. dell’11 maggio 1999 n. 152, sostanzialmente
confermato dal successivo D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 258.
Tale
svolta, più che per volere dell’ordinamento italiano, fu necessaria per
adeguarsi alle linee guida imposte dalle direttive UE.
·
La
depenalizzazione
La Legge Merli inseriva al suo interno delle tabelle le quali individuavano ben 51 diversi parametri da dover rispettare da parte del responsabile dello scarico acque reflue al fine di evitare una denuncia penale.
Nella
lettura dell’attuale D. Lgs. n. 152/1999, anche a seguito delle modifiche
apportate dal D. Lgs. n. 258/2000, all’art. 59 si evidenzia la
depenalizzazione per ben 33 sostanze, ovvero il reato viene a sussistere solo
per un numero limitato di 18 sostanze (arsenico, cadmio, cromo, piombo e poche
altre). Poiché tali sostanze pericolose sono tipiche di limitate produzioni
dell’industria italiana come pure non si trovano negli scarichi di tutti gli
allevamenti zootecnici italiani, si verifica che molti potranno scaricare
rischiando unicamente la sanzione amministrativa. E, in una normativa che si
prefigge la protezione dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti
agricole, desta meraviglia la depenalizzazione per parametri come azoto
nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo, BOD, COD, pesticidi vari.
Inoltre, nel verificare l’entità della sanzione amministrativa, si scopre
che essa è solo simbolica poiché parte da solo cinque milioni di lire.
Ad
avviso del Dott. Amedeo Postiglione, Consigliere della Corte Suprema di
Cassazione, questa depenalizzazione deve essere “denunciata con forza
all’attenzione del Parlamento Italiano e degli organismi dell’Unione
Europea; in una materia tanto delicata, il Parlamento avrebbe dovuto evitare
la delega al Governo per scongiurare eccessi come quelli verificatesi
soprattutto con riferimento al sistema sanzionatorio reso inefficace non per i
profili formali ma per quelli sostanziali, attinenti alla messa in pericolo ed
alla lesione del bene ambiente”[1].
In
effetti, l’applicazione della Direttiva 91/271/CEE, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane, che prevede, con un ritardo di dieci
anni, lo spostamento al 31/12/2016 del raggiungimento degli obiettivi di
qualità ambientali e dei piani di tutela
delle acque (artt. 4 e 44 del nuovo
D. Lgs. n. 152/1999), la possibilità data alle
Regioni
di introdurre limiti meno restrittivi rispetto a quelli statali, salvo che per
le sostanze indicate nelle tabelle dell’allegato 5 (art. 28 comma 2), la
possibilità di effettuare accordi di programma con i soggetti economici
interessati “anche in deroga alla disciplina generale” (art. 28 comma 10)
e la depenalizzazione di tutto il settore degli scarichi di acque reflue
domestiche e di reti fognarie (art. 54 commi 1, 2, 3) fa appunto presagire un
intento da parte del Governo a non voler ancora affrontare con la giusta
ponderazione il problema Ambiente.
La
giurisprudenza, comunque, si è già espressa in modo contrario a quanto
affermato dal Dott. Postiglione; la sentenza della Cassazione penale, sezione
III, del 9 agosto 2000, n. 2808, afferma: “Il nuovo regime tabellare
previsto dalle tabelle dell’allegato 5 del D. Lgs. n. 152/1999 non può,
sotto l’aspetto tecnico, essere comparato con quello precedente fissato
dalla legge 319/1976 (tabelle A e C). Pur se i valori numerici relativi ai
diversi parametri previsti dalla legge 319/1976 sono in generale eguali a
quelli indicati anche dalla tabella 3 del D. Lgs. 152/1999, di fatto nel suo
complesso il regime dei limiti attuali è notevolmente diverso da quello
vigente in precedenza. Infatti sono previsti limiti per sostanze che prima non
erano previste e sono previsti limiti distinti per sostanza che prima, in
quanto facenti parte di un’unica famiglia, erano soggetti invece ad un
limite cumulativo. Inoltre, le modalità ed il punto di controllo dei limiti,
la proibizione espressa di miscelare anche all’interno dello stesso
stabilimento correnti di scarico diverse, contenenti particolari sostanze
inquinanti, indiscutibilmente, comportano di fatto condizioni diverse per il
rispetto dei limiti.
Conseguentemente
i due regimi, pur a parità dei valori numerici dei limiti, non risultano
confrontabili”.
Subito
però la sentenza continua con una affermazione di un certo peso e
precisamente: “L’applicazione della sanzione penale soltanto in relazione
alle sostanze indicate nella tabella 4 ex art. 59 comma 5 del D. Lgs. 152/1999
(ossia le 18 sostanze ritenute più pericolose) e la contestuale applicazione
delle sanzioni amministrative ex art. 54, primo comma per il superamento dei
limiti tabellari, ha un senso pratico e giuridico soltanto alla fine del
periodo transitorio di adeguamento e non prima altrimenti riduce la effettività
del sistema e comporta di fatto la depenalizzazione generalizzata di molti
procedimenti penali”.
Ma
in questo periodo di transizione va inoltre segnalata una disparità di
trattamento[2]
tra i titolari di scarichi nuovi che superino i limiti previsti per le
sostanze pericolose (i quali possono essere colpiti in via amministrativa, ex
art. 54, comma 1) ed i titolari di scarichi esistenti, per i quali scatta la
sanzione penale prevista dal combinati disposto di cui agli artt. 59, comma 2
e 62, comma 12 del D. Lgs. 152/1999.
Infatti
per gli scarichi esistenti la violazione dei limiti non è assoggettata né
alle sanzioni penali previste dall’art. 59 quinto comma né a quelle
amministrative previste dall’art. 54 primo comma, che rappresentano la
“nuova disciplina” applicabile solo dopo il periodo transitorio; si
applica per tali scarichi una diversa e specifica,
e purtroppo molto blanda, sanzione penale tipica del periodo intermedio
ex art. 62 comma 12 del D. Lgs. n. 152/1999.
La
sentenza si fa carico del problema affermando però, che “si tratta di una
scelta del legislatore che non può essere corretta per via interpretativa,
ostandovi il chiaro dettato testuali degli artt. 59 commi 2 e 3 e 62 commi 11
e 12 e che rende opportuno un intervento del Governo e del Parlamento”.
· Gli scarichi esistenti
Per concetto di scarico “esistente” bisogna considerare non solo l’esistenza meramente fisica al momento dell’entrata in vigore della norma (29 maggio 1999, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. n. 152/1999), ma occorre fare riferimento alla sussistenza o meno dell’autorizzazione ed allo stato di procedura d’appalto ed all’assegnazione dei lavori.
I titolari di scarichi esistenti (e già autorizzati) godono, in base all’art. 62 comma 11, di un periodo transitorio di tre anni per adeguarsi ai nuovi limiti ma, nel frattempo,
devono adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento, nonché rispettare le eventuali prescrizioni imposte dalle Regioni o da altre autorità competenti (art. 62 comma 12).
L’art. 54 comma 4 e l’art. 59 comma 2 prevedono appunto l’applicazione di una sanzione amministrativa o penale, a seconda che si tratti di scarichi di acque reflue urbane o industriali, per chiunque effettui, al momento dell’entrata in vigore del decreto, scarichi autorizzati in base alla normativa previgente ma senza ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 62, comma 12.
Da notare comunque che solo nell’art. 54 comma 4, le parole “autorizzati in base alla normativa previgente” sono state sostituite, col decreto di modifica al D. Lgs. n. 152/1999, da “esistenti”, equiparando la norma in esame a quella espressamente richiamata di cui all’art. 62 comma 12: “coloro che effettuano scarichi esistenti di acque reflue ….”.
Sia la dottrina sia la giurisprudenza[3] sono comunque di opinione comune nel considerare il concetto di “scarichi esistenti” analogo a quello di “scarico precedentemente autorizzato” e pertanto è da ritenere che il mancato adeguamento della disposizione di cui all’art. 59 comma 2 sia imputabile solo ad una svista del legislatore.
·
Il
nuovo articolo 56
Le novità introdotte dal legislatore con il D. Lgs. n. 258/2000 non vanno ad effettuare delle modifiche sostanziali all’assetto della norma, ma contengono piuttosto alcune precisazioni che sono: A) l’eliminazione nel comma 1 dell’art. 56 del rinvio espresso alle disposizioni della legge n. 689/1981 (modifiche al codice penale); B) l’attribuzione della facoltà alle Regioni od alle Province autonome di delegare, ad altra autorità, la propria competenza; C) l’introduzione del comma 1-bis con la
funzione di precisare la competenza concorrente del corpo forestale dello stato, in qualità di polizia specializzata in materia ambientale, nella sorveglianza e nell’accertamento degli illeciti in materia di tutela delle acque.
In
merito alla seconda modifica si ha pertanto che la Provincia ed il Comune sono
oggi competenti ad applicare anche le sanzioni amministrative introdotte dalla
nuova normativa sulle acque, in relazione agli scarichi di rispettiva
competenza.
Ultima
osservazione è che nel testo emendato dell’art. 56 non viene tenuto conto,
nella parte in cui si attribuisce per alcuni illeciti la competenza al Comune,
del fatto che il comma 9, a cui si continua a far riferimento, è stato
abrogato e contestualmente trasformato in illecito penale ex art. 59 comma
6-ter.
·
La
mancata osservazione delle prescrizioni indicate nel provvedimento di
autorizzazione.
Una ulteriore osservazione si ha dal confronto tra l’art. 54 comma 3 del nuovo D. Lgs. 152/1999 “Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1,[4] effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione …. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni” e l’art. 59 comma 4 del medesimo decreto “Chiunque … effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose[5] comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5, senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, ….. è punito con l’arresto fino a due anni”.
Dalla lettura di questi due commi si conclude che chi effettua scarichi senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e senza superare i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5, è assoggettato a sanzione amministrativa o penale ed alla applicazione dell’art. 51 “Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico”.
Qualora invece si osservino le prescrizioni dell’autorizzazione ma vengano superati i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5, si applicano solamente le norme appositamente previste per il superamento dei limiti di accettabilità dello scarico autorizzato.
Sembrerebbe pertanto che in tale situazione si debba escludere l’applicazione del procedimento di diffida, sospensione o revoca dell’autorizzazione previsti dall’art. 51.
Da una attenta lettura e dalle seguenti osservazioni
1) la maggior gravità della sanzione prevista per il superamento dei limiti tabellari rispetto a quella comminabile per la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
2) il riferimento generale espresso dall’art. 51 del D. Lgs. n. 258/2000, ossia all’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, possa comprendere anche il superamento dei limiti tabellari;
3) il fatto che il provvedimento di diffida e la contestuale sospensione dell’autorizzazione come pure di revoca sia connesso ad una concreta situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
4) la considerazione che le previsioni tabellari sono poste a diretta tutela della salute pubblica e dell’ambiente;
si può ritenere che i provvedimenti di cui all’art. 51 siano giustificatamente applicabili anche alle violazioni delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione attinente ai limiti di emissione degli scarichi.
·
L’immissione occasionale
La
Legge Merli sanzionava l’immissione occasionale effettuata senza la
prescritta autorizzazione, come
risulta da numerose pronunce emesse dalla Corte di Cassazione
che
interpretavano la nozione di scarico in senso onnicomprensivo[6].
Nel
vecchio D. Lgs. n. 152/1999, poiché l’immissione occasionale veniva
collegata allo scarico con riferimento al superamento dei valori limite
stabiliti dalle tabelle allegate al decreto, si verificava che né il comma 1
dell’art. 59 prevedeva come reato l’apertura o l’effettuazione di una
immissione occasionale con riferimento alla mancata autorizzazione, né il
comma 2 dell’art. 56 prevedeva come illecito amministrativo la medesima
situazione. Pertanto solo nel caso del superamento dei limiti di accettabilità
imposti dagli art. 59 comma 5 e art. 54 comma 1 del decreto in questione
l’immissione occasionale trovava esplicita disciplina. A conferma di ciò la
Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza del 14 settembre 1999[7],
stabilì che “alla stregua del combinato disposto degli artt. 2, lett. h) e
bb), 45, comma 1 e 59, commi 1 e 5, del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, le
immissioni occasionali non autorizzate di acque reflue industriali non
costituiscono reato salvo che diano luogo al superamento dei valori limite
fissati nella tabella 3 allegata al suddetto decreto legislativo, essendo
penalmente sanzionato per difetto di autorizzazione solo il vero e proprio
“scarico”, il quale deve avvenire “tramite condotta”, e cioè a mezzo
di qualsiasi sistema stabile – anche se non esattamente ripetitivo e non
necessariamente costituito da una tubazione – di rilascio delle acque
predette”. Nei motivi della decisione si leggono i seguenti passaggi
fondamentali: “….dal testo della norma si evince che la legge vigente
distingue nettamente tra “scarico” ed “immissione occasionale”. Lo
“scarico” è collegato alla nozione di “condotta”, che non deve essere
intesa nel senso restrittivo di tubazione ma come qualsiasi sistema stabile
– anche se non esattamente ripetitivo e
non necessariamente costituito da una tubazione – di passaggio o
deflusso delle acque reflue. La nuova legge punisce con arresto o ammenda
soltanto lo scarico di nuove acque reflue industriali, se effettuato senza
autorizzazione, non prevede invece, la medesima sanzione per l’immissione
occasionale. …. Va fissato, pertanto il seguente principio: il decreto
legislativo
n. 152/1999 ha modificato la precedente disciplina della legge n.
319/1976 ed ha distinto (art. 59) tra scarico di acque reflue industriali ed
immissione occasionale. Il primo deve avvenire tramite condotta (art. 2, lett.
bb), e cioè, a mezzo di qualsiasi sistema stabile – anche se non
esattamente ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione –
di rilascio delle acque predette, il secondo ha il carattere
dell’eccezionalità collegata con la menzionata “occasionalità”. Ne
deriva che questo secondo comportamento non è più previsto come reato con
riferimento alla mancanza di autorizzazione, mentre è ancora tale in
relazione al superamento dei limiti tabellari di accettabilità, poiché
espressamente disciplinato (art. 59, comma 5)”.
Con
l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 258/2000 il comportamento di chiunque
superi i limiti tabellari nell’effettuazione di un’immissione occasionale,
indipendentemente dalla natura dell’immissione stessa, non risulta più
sanzionato né a livello amministrativo (art. 54 comma 1), né a livello
penale (art. 59 comma 5).
Ai
sensi dell’attuale disciplina sulle acque, l’occasionalità della
immissione risulta pertanto non sanzionabile.
Purtroppo
questo vuoto normativo sembra non poter essere sanabile neppure attraverso una
interpretazione estensiva della nozione di scarico, da poter ricomprendere
anche il concetto di episodicità; infatti, nell’art. 2 lettera bb) del
modificato D. Lgs. n. 152/1999 il legislatore, nel fornire la
definizione di scarico, ha voluto chiaramente escludere dal suo ambito di
applicazione gli sversamenti od i rilasci non riconducibili ad una struttura
stabile.
In
ogni caso, viste le relazioni tra la normativa in materia di acque e quella
sui rifiuti di cui al D. Lgs. n. 22/1997, ovvero “Decreto Ronchi”, il
quale, se pur limitatamente, disciplina il concetto di rifiuto liquido ossia
nel caso di mancanza di collegamento diretto e funzionale tra titolare dello
scarico e corpo recettore, l’immissione occasionale risulta non sanzionata
dalla normativa sulle acque ma vietata dall’art. 14, comma 2, del
“Decreto Ronchi”, che espressamente dispone che “è altresì vietata
l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido,
nelle acque superficiali e sotterranee”.
Questo
divieto trova poi la sua sanzione amministrativa e penale nell’art. 50,
commi 1 e 2, del “Decreto Ronchi”.
Infine,
qualora l’immissione occasionale sia non voluta ma accidentale (fuoriuscita
di olio da cisterna ad esempio), bisognerà rifarsi all’art. 674 del codice
penale, il quale sanziona il comportamento di chiunque getti o versi …. cose
atte a offendere o imbrattare o molestare persone, intendendo col termine
“molestia” ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo al
normale vivere quotidiano[8].
E’
ultimamente intervenuta la Cassazione penale, sezione III, che, con la
sentenza
n. 11710 del 15 novembre 2000, ha stabilito che è riconducibile al
reato di danneggiamento aggravato previsto dall’art. 635, comma 2 del codice
penale (arresto da sei mesi a tre anni), l’ipotesi di grave inquinamento e
più precisamente “integra gli estremi del delitto lo scarico di sostanze
inquinanti o deturpanti in acque pubbliche, comportando, anche nell’ipotesi
di fatto occasionale e transitorio, il deterioramento di cosa mobile destinata
ad utilità pubblica”.
Tale
sentenza sottolinea il principio in base al quale, indipendentemente dalle
violazioni formali alla normativa tecnica del settore, chi con uno scarico
crea un danno ambientale alle acque pubbliche risponde comunque, dal punto di
vista penale, della condotta tenuta.
·
L’articolo 58
Il
comma 1 dell’art. 58 del D. Lgs. 152/1999 recita: “Chi con il proprio
comportamento omissivo o commissivo …. provoca un danno alle acque, al
suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali, ovvero determina un
pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere
a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale delle aree inquinate ….”. A detta del Dott. A.
Postiglione [9],
anche se tale articolo appare ben strutturato, tale reato opera a valle del
sistema e pertanto dal punto di vista tecnico è di difficile attuazione (non
esistono ad oggi ancora nessun caso di applicazione[10]).
Ma non solo; se andiamo a leggere il comma 4 dell’art. 58 troviamo scritto
“Chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, è punito con
l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da lire cinque a lire
cinquanta milioni”. E’ osservabile che l’ammenda di cinquanta milioni può
risultare facilmente di importo irrisorio rispetto all’effettivo costo di
bonifica che si potrebbe dover sostenere per bonificare determinate aree.
· Il gestore degli impianti
Con
il comma
6 dell’art.
59 D.
Lgs. 152/1999,
il legislatore
ha introdotto,
per
la
prima volta, un’autonoma figura di reato a carico del gestore degli
impianti di trattamento acque, distinto da quello del titolare dello scarico.
La necessità di introdurre questa particolare “figura criminosa”, che
indica come soggetto attivo esclusivamente il gestore, trova giustificazione
nel semplice fatto di poter attribuire al soggetto qualificato particolari
doveri e responsabilità.
Tale
comma è stato comunque modificato dal D. Lgs. 258/2000 in quanto è stata
eliminata la limitazione soggettiva alla sola colpa grave o al dolo per il
fatto commesso dal gestore.
Pertanto,
quando il comma 5 dell’art. 59 recita “Chiunque, nell’effettuazione di
uno scarico di acque reflue industriali ….” è da intendersi con tale
pronome sia il titolare dello scarico, sia il gestore dell’impianto di
trattamento.
Il
legislatore ha comunque voluto sostituire nell’art. 59 la figura del gestore
di impianti di depurazione, soggetto che persiste nell’art. 45 comma 2, con
quella del gestore di impianti di trattamento acque reflue urbane e del
gestore di impianti di trattamento acque reflue industriali. Questa modifica,
che limita l’applicabilità del comma 6 al solo gestore di impianti di
trattamento acque reflue urbane, è spiegabile solo mettendo in relazione la
lettura di tale comma con quanto stabilito nel comma 5 dello stesso articolo.
Il
comma 5 sanziona il superamento dei limiti tabellari, in relazione alle
sostanze pericolose, per lo scarico di acque reflue industriali. Tale reato è
qualificabile come comune, ossia commettibile da chiunque, anche dal gestore
di impianti di trattamento di acque reflue industriali. Non può invece essere
soggetto attivo di questo reato il gestore di impianti di trattamento
di acque reflue urbane, se non in violazione del principio di legalità.
Ma
proprio per non escludere tale ipotesi, il legislatore ha esteso la punibilità,
nella sola ipotesi di superamento dei limiti tabellari per determinate
sostanze, anche al gestore degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane, prevedendo una sanzione analoga a quella del comma 5.
·
Nuove
sanzioni amministrative e penali.
Il D. Lgs. n. 258/2000 ha aggiunto nuovi illeciti amministrativi e nuovi reati penali. In merito agli illeciti amministrativi sono stati introdotti due nuovi commi all’art. 54 e precisamente il comma 10-bis e 10-ter, i quali prevedono appunto delle sanzioni amministrative qualora non si rispettino i vari obblighi definiti dalle Regioni. Infatti, come già in precedenza accennato, il decreto in questione, all’art. 22 comma 3 e all’art. 39 comma 1, attribuisce vari compiti alle Regioni, che vanno dal definire gli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati, alle particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione, per immissioni di acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate.
Il D. Lgs. n. 258/2000 ha inoltre trasformato in illeciti penali alcuni comportamenti che prima costituivano mere trasgressioni amministrative e precisamente sono: la violazione delle prescrizioni concernenti l’installazione, la gestione dei controlli in automatico e la violazione dell’obbligo di conservazione dei risultati stessi (art. 59 comma 4-bis); l’autorità competente al controllo, in virtù di quanto espresso dall’art. 52, ha la facoltà di ordinare, per gli scarichi pericolosi, l'installazione di strumenti di controllo che consentano un’efficace verifica sulle modalità di gestione degli impianti stessi. L’inottemperanza delle prescrizioni stabilite dall’autorità di controllo comporta oggi l’applicazione di una sanzione penale, cioè l’arresto fino a due anni.
Un secondo caso riguarda l’impedimento dell’accesso da parte del soggetto incaricato del controllo (art. 59 comma 6-ter). Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte degli organi di controllo che sono autorizzati, in ogni momento, ad effettuare qualunque ispezione risulti essere necessaria ai fini dell’accertamento delle condizioni dello scarico. L’impedimento dell’accesso dell’autorità competente è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l’arresto fino a due anni; se l’impedimento dell’accesso viene fatto utilizzando violenze o minaccia, la fattispecie in esame concorre con il delitto di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a pubblico ufficiale), punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Nuove fattispecie criminose si individuano a seguito dell’introduzione dei commi 6-bis, 6-quater, 11-bis e 11-ter dell’art. 59 .
Al comma 6-bis si introduce una sanzione penale per il gestore del servizio idrico integrato[11] che:
1) non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 36 comma 3 (il gestore deve comunicare all’autorità competente l’accettazione di: A) rifiuti costituiti da acque reflue purché rispettosi dei limiti stabiliti per lo scarico in fognatura, B) rifiuti costituiti dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche, C) rifiuti costituiti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria, da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente od economicamente irrealizzabile);
2) non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all’art. 36 comma 5 (indicazione nella
comunicazione all’autorità competente di cui al comma 3, della capacità residua dell’impianto e delle caratteristiche e qualità dei rifiuti da trattare; ottemperanza degli eventuali divieti indicati dall’autorità competente per il trattamento di specifiche categorie di rifiuti).
Significativo è che la pena prevista sia quella dell’art. 51 comma 1 del D. Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi); questo perché si ha la conferma della piena riferibilità delle operazioni previste dall’art. 36 del nuovo D. Lgs. n. 152/1999 alla gestione dei rifiuti, sia pure con aggiustamenti procedimentali connessi alla particolarità dello smaltimento. Il rinvio alla sanzione prevista dall’art. 51 comma 1 del “decreto Ronchi” caratterizza il reato in esame come contravvenzione ; ciò comporta un regime di prescrizione più favorevole (due o tre anni, a seconda che la pena stabilita sia esclusivamente pecuniaria o alternativa), nonché la possibilità di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma in denaro (oblazione) se la pena comminata è pecuniaria o alternativa.
Il
comma 6-quater punisce con le sanzioni di cui all’art. 59 comma 1, chiunque
non ottemperi alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell’art. 39,
comma 3. Le Regioni devono disciplinare i casi in cui le acque di prima
pioggia e di lavaggio delle aree esterne vengono convogliate e trattate in
impianti di depurazione, per ipotesi particolari in cui si possa verificare il
rischio di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte di sostanze
pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di
qualità dei corpi idrici.
La
mancata osservanza della disciplina dettata dalle Regioni è penalmente
sanzionata, con una misura alternativa i cui limiti edittali variano a seconda
che si tratti di rifiuti non pericolosi o pericolosi. Si tratta di una norma
penale “in bianco”, in cui la sanzione è determinata, mentre il precetto
ha carattere generico dovendo essere necessariamente specificato da un atto
normativo di grado inferiore (la legge regionale); inoltre, secondo quanto
disposto dall’art. 117 della Costituzione, l’attuazione del decreto
legislativo in oggetto può avvenire solo tramite una legge della
Regione e non a mezzo di un altro provvedimento amministrativo.
Il
Veneto non ha ancora affrontato tale problema.
Per
il comma 11-bis: “la sanzione di cui al comma 11[12]
si applica anche a chiunque effettua, in violazione dell’art. 48 comma 3, lo
smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico
attraverso condotte ovvero altri mezzi o comunque effettua l’attività di
smaltimento di rifiuti nelle acque marine senza essere munito
dell’autorizzazione di cui all’art. 18 comma 2 lettera p-bis del
D. Lgs. n. 22/1997”.
L’art.
48, comma 3, chiarisce che, ferma restando la disciplina contenuta
nel D. Lgs. n. 99/1992[13],
i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue rimangono sottoposti
alla disciplina sui rifiuti che trova, in questo caso, applicazione esclusiva;
esso precisa che: A) lo smaltimento dei fanghi in acque marine è autorizzato,
come ogni rifiuto avente la medesima destinazione, ai sensi dell’art. 18,
lettera p-bis,
D. Lgs. n. 22/1997, dal Ministero
dell’Ambiente; lo svolgimento di questa attività senza la prescritta
autorizzazione, trova la sua sanzione nel comma 11-bis
dell’art. 59; B) deve, in ogni caso, cessare entro il 2003; C) fino a
questa data, le quantità totali di materie tossiche devono essere
progressivamente ridotte; D) le modalità di smaltimento devono rendere minimo
l’impatto negativo sull’ambiente.
La
violazione di queste prescrizioni, oggi considerata reato e sanzionata con la
pena detentiva dell’arresto da due mesi a due anni, non trovava nel vecchio
testo del
D. Lgs. n. 152/1999 alcuna esplicita sanzione.
Infine,
l’inosservanza del divieto di smaltimento dei fanghi nelle acque
superficiali dolci e salmastre, introdotto dall’art. 48, comma 2, continua a
essere punito solo con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire
dieci milioni a lire cento milioni.
Una
sanzione penale specifica è stata infine introdotta in tema di utilizzazione
agronomica di effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi
oleari nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole
aziende agroalimentari di cui all’art. 38.
Da
precisare che tale norma è stata interamente sostituita dal D. Lgs. n.
258/2000[14],
il quale, pur confermando che i criteri e le norme tecniche generali per
l’attività di utilizzazione agronomica dovranno essere adottati con decreto
del ministro delle politiche agricole e forestali, rinvia alla normativa
regionale per quanto concerne la disciplina dell’attività stessa (le
modalità di attuazione degli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge 574/1996; i tempi
e le modalità della comunicazione; i casi di esonero dall’obbligo di
comunicazione; le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo
agronomico; le procedure ed i criteri di controllo; il divieto di esercizio o
la sospensione dell’attività in caso di mancata comunicazione o mancata
osservanza delle prescrizioni impartite; le sanzioni amministrative
pecuniarie, fermo restando quanto disposto dall’art. 59 comma 11-ter).
La
disposizione di cui al comma 11-ter dell’art. 59 è una normativa penale in
bianco; anche in questo caso mentre la sanzione è determinata, il precetto
deve necessariamente essere specificato dalla normativa regionale.
Infatti, l’attuale sanzione penale (ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni o arresto fino ad un anno) riguarda l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure previste dalla disciplina regionale, ovvero in violazione del divieto o dell’ordine di sospensione dell’attività impartito dall’autorità competente.
Per
quanto concerne la fase transitoria, lo stesso comma 11-ter sanziona
penalmente anche “chiunque effettua l’utilizzazione agronomica al di fuori
dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”; va però tenuto
presente anche l’art. 57, comma 7, il quale punisce con sanzione
amministrativa la violazione delle norme regionali emanate prima
dell’adeguamento alle nuove regole di cui all’art. 38. Il coordinamento
tra le due norme, atteso che anche la disciplina regionale ad oggi emanata in
tema di utilizzazione agronomica è normativa vigente, non si presenta agevole
e sicuramente darà luogo a contrasti interpretativi.
· Il campionamento
Un’ultima precisazione da segnalare, anche se non riguarda direttamente il sistema sanzionatorio, ma che non mancherà di avere incidenza nell’applicazione dello stesso, deriva dalla lettura del punto 1.2 dell’allegato 5 che al secondo comma recita: “Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. L’autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.) ”.
Avviene
quindi che nella scelta del metodo di campionamento dei reflui sussiste una
discrezionalità tecnica, così che l’indicazione di effettuare l’analisi
su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, poiché
il tipo di campionamento è correlato non solo alle caratteristiche del ciclo
produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata ed alla durata dello
scarico.
Non
solo; dato che nei procedimenti penali riguardanti violazioni di norme poste a
tutela dell’ambiente assumono, ai fini probatori, notevole rilevanza le
attività di campionamento ed analisi, le quali spesso rappresentano l’unico
mezzo per verificare l’effettiva sussistenza della violazione contestata,
ulteriore motivo di perplessità è dato dalla distinzione, operata in alcuni
casi da dottrina e giurisprudenza, tra la nozione di accertamento e quella di
rilievo, quest’ultimo costituito dalla semplice raccolta di dati ed altri
elementi descrittivi che non necessita, a differenza dell’accertamento, di
alcuna valutazione critica da parte del soggetto che l’ha effettuata. Questa
situazione crea incertezza sull’individuazione della corretta condotta da
tenere, sull’istituto processuale da applicare e sul relativo strumento
processuale utilizzabile, e ciò espone l’attività compiuta a possibili
eccezioni di nullità. La particolarità dell’attività da compiere, la
deperibilità dei campioni, la possibilità di alterare o modificare gli
impianti od i materiali da analizzare rendono difficoltosa la scelta
dell’istituto processuale concretamente applicabile.
Appare
tuttavia possibile, fino ad un risolutivo intervento in tal senso, far ricorso
a soluzioni pratiche (acquisizione di documentazione presso l’insediamento
da controllare – documentazione contabile relativa all’acquisto di materie
prime, referti di analisi fatte effettuare dai titolari dell’insediamento
– documentazione fotografica o audiovisiva della situazione riscontrata)
che, sfuggendo a formalismi inutili e dannosi, siano basate su semplici regole
di buon senso[15].
La
mancanza di istituti processuali specificamente dedicati all’attività di
analisi dovrebbe indurre il giudice ad una valutazione a posteriori
dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari che prescinda
dallo strumento processuale utilizzato e che tenga conto, esclusivamente,
dell’effettivo rispetto delle garanzie di difesa.
Vecchio
D. Lgs. 152/1999
CAPO
I: Sanzioni amministrative e danno ambientale
54.
Sanzioni amministrative.
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico ovvero di una immissione occasionale, supera i valor