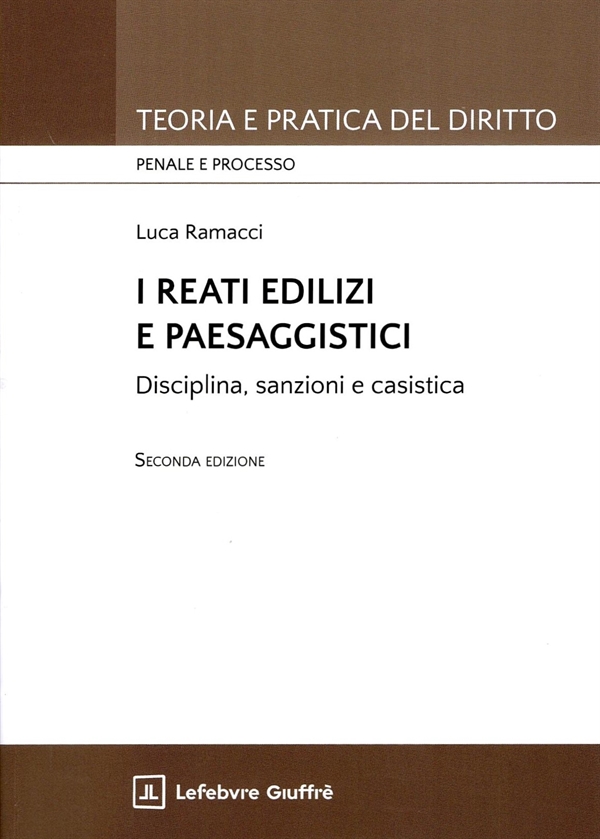UN FONDAMENTALE RICHIAMO ALLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI UN BENE
PAESAGGISTICO O CULTURALE
- Nota a commento della sentenza della Corte di Cassazione n. 44275 del 5
dicembre 2005 -
A cura del Dott. Massimo Latini
La sentenza può essere letta
qui
Con la sentenza in commento, la III Sezione Penale della Corte Suprema di
Cassazione ha recentemente espresso una netta posizione sulla insorgenza della
disciplina vincolistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (il cosiddetto “Codice Urbani”).
In particolare, si chiarisce, relativamente alla procedura di individuazione di
un bene paesaggistico (o, per estensione, di un bene culturale), che l’unica via
possibile per porlo in essere è quella prevista dall’anzidetto codice.
Ne deriva che l’insorgenza del regime vincolistico dovrà essere notificata al
proprietario del suolo e non potrà essere, in via autonoma, imposta direttamente
dall’autorità comunale competente per mezzo dei piani regolatori o per mezzo di
altri strumenti urbanistici che stabiliscono le destinazioni d’uso del
territorio comunale.
*****
Il fatto ha avuto origine da un accertamento avvenuto in Castrignano del Capo
(LE) il 27 maggio del 2000, nel quale fu rilevata la modifica del preesistente
natural declivio di un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico senza il
necessario nulla-osta. Più precisamente, fu contestata la trasformazione di una
zona di circa 5000 mq. avvenuta attraverso il riporto di materiale di risulta,
portando di fatto al conseguente livellamento del fondo.
La proprietà del terreno fu pertanto individuata quale responsabile della
contravvenzione di cui all’articolo 1 sexies della legge 5 agosto 1985, n. 431
(la cosiddetta “legge Galasso”), riprodotto nell’articolo 163 del d.lgs. 29
ottobre, n. 490, ora articolo 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (articolo
che rimanda all’articolo 20 della legge n. 47 del 1985, ora sostituito
dall’articolo 44.1 del DPR n. 380 del 2001). Il Tribunale di Lecce condannava
l’imputato alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 8000.00 di ammenda, quale
responsabile della suddetta contravvenzione.
Successivamente, in sede di ricorso d’appello, la pena fu confermata anche dalla
Corte di Appello della medesima città. A fondamento della decisione la corte
adita confermava, oltre che la legittimità della sussistenza del vincolo
paesaggistico, anche che il comportamento ascritto all’imputato aveva
indubbiamente configurato il reato contestato.
Ciò evidenziando, in particolare, come la “compatibilità ambientale” espressa
dall’autorità amministrativa locale con l’autorizzazione paesaggistica
rilasciata dal competente comune non poteva estinguere il reato menzionato.
In materia paesaggistica, infatti, l’autorizzazione in sanatoria di un
intervento realizzato abusivamente prevede come unica conseguenza favorevole
l’esclusione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in deroga
anche al comma 2 dell’articolo 181 del citato Codice dei beni culturali e del
paesaggio d.lgs. n. 42/04 (d’ora in avanti abbreviato in “codice”).
Il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione dell’imputato si è fondato su tre
motivi.
Il primo lamentava l’erronea applicazione dell’articolo 1 sexies della legge
431/1985 in quanto la condotta ravvisata non integrava il reato contestato,
poiché non sarebbe avvenuta alcuna modifica rilevante dello stato dei luoghi.
Infatti, il materiale di risulta riportato sul terreno, in quanto costituito
solamente da terra e pietrisco, sarebbe stato omogeneo alla natura del fondo
agricolo interessato. Il successivo spianamento dell’area, inoltre, non avrebbe
alterato le caratteristiche del suolo.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha dichiarato infondato tale primo
motivo, in quanto nelle zone poste a vincolo paesaggistico è inibita ogni
modificazione dell’assetto del territorio senza la preventiva autorizzazione, ad
esclusione di alcuni particolari e limitati interventi (come, ad esempio, quelli
di manutenzione ordinaria o straordinaria, quelli relativi all’esercizio
dell’attività agro-silvo-pastorale, oppure quelli consistenti nel taglio
colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, ecc.,
ancorché nei limiti previsti dall’articolo 149 del codice), che non riguardano
comunque il fatto in esame.
Trattandosi di reato di pericolo astratto, non potrebbe neanche ravvisarsi la
possibilità secondo la quale la condotta dell’imputato possa essere esclusa in
quanto non abbia, di fatto, prodotto un effettivo pregiudizio per l’ambiente.
L’illecito si configura in ogni caso, dovendo la legge garantire, attraverso
l’autorizzazione, una preventiva valutazione dell’impatto delle opere sul
paesaggio.
Osservazioni, queste ultime, sicuramente in linea con l’intenzione del
legislatore, che rientrano, tra l’altro, all’interno di un consolidato
orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il reato sussiste
sempre e comunque, anche se la condotta posta in essere non compromette il
valore paesaggistico o l’aspetto esteriore degli edifici (cfr., ad esempio,
Cass. Sez. III n. 33297 del 2005).
Nella fattispecie, oltre tutto, il materiale riportato consisteva in larga
misura da residui di ristrutturazioni edili e solo in minima parte da terra,
raggiungendo un’altezza di quattro metri per una superficie di circa 5000 mq.,
compromettendo concretamente i valori paesaggistici oggetto della tutela.
Diversamente, la seconda motivazione è stata giudicata fondata dalla Corte di
Cassazione, portando a conclusioni e considerazioni rilevanti e determinanti ai
fini dell’individuazione della sussistenza di un vincolo, tanto da creare, in
senso generale, un precedente di rilievo in materia.
Il ricorrente lamentava un difetto di motivazione, in quanto il vincolo
paesaggistico insistente sul fondo in parola poteva essere imposto solamente da
una legge statale o regionale e non attraverso un provvedimento amministrativo
comunale. Già il primo giudice sul punto si era limitato a richiamare la
deposizione del tecnico comunale, il quale aveva genericamente affermato la
sussistenza di un vincolo di natura paesaggistica e idrogeologica senza alcuna
ulteriore esplicitazione, lasciando intendere che il vincolo sarebbe stato
imposto dal comune interessato.
La Corte d’Appello, sul punto, si era limitata a respingere il ricorso
osservando che il vincolo di che trattasi era un “atto effettivamente
rilevante”, senza però indicare né l’autorità che l’avrebbe imposto, né l’atto
impositivo di individuazione, senza di fatto espletare adeguatamente, a detta
della Suprema Corte, l’accertamento della reale sussistenza del vincolo. Era
chiaro solamente che l’autorizzazione postuma (di cui all’articolo 146 del
codice) è stata rilasciata dal comune competente, ma non era chiaro se quale
delegato dell’autorità regionale o quale autorità amministrativa che avrebbe
imposto il vincolo.
La procedura di individuazione di un bene paesaggistico (o culturale) prevede
una procedura piuttosto complessa (ad esclusione di quelli imposti per legge, di
cui all’articolo 142 del codice), che esclude in ogni caso la possibilità che
l’autorità comunale possa imporli autonomamente per mezzo dei piani regolatori o
per mezzo di altri strumenti urbanistici che stabiliscono la destinazione d’uso
del territorio comunale.
Nel caso in esame non risultava chiara né la natura del vincolo né l’autorità
che lo avrebbe imposto.
Per questi motivi la Corte di Cassazione ha deciso di annullare la decisione
della Corte d’Appello rinviandola ad altra sezione per un nuovo esame, al fine
di accertare la legittima imposizione del vincolo prescritto per legge e,
nell’eventualità che detto vincolo fosse stato imposto dal comune, dovrà
accertare se questo fosse munito di apposita delega.
L’esame della terza motivazione, relativa alla mancanza di motivazione in ordine
alla valenza della declaratoria di compatibilità ambientale contenuta
nell’autorizzazione, si è resa superflua essendo logicamente prioritaria la
definizione della legittima sussistenza del vincolo.
*****
Esposta brevemente la sentenza in commento, è bene meglio specificare
l’importanza della sentenza stessa alla luce di una prassi ormai consolidata di
applicazione della norma che vede da tempo uno svuotamento sostanziale del
dettato e dei principi del tutto innovativi, ancora a distanza di più di vent’anni,
della cosiddetta “legge Galasso” (ora di fatto assorbita, senza modifiche
sostanziali, nel cosiddetto “Codice Urbani”).
Principi che hanno innovato la concezione della legge n. 1497 del 1939 sulle
bellezze naturali, secondo la quale l’insorgenza di un vincolo era subordinata
all’aspetto puramente estetico e visivo del paesaggio da tutelare, con tutti i
limiti che ne conseguivano. E’ partendo da questi limiti che col passare del
tempo, presto si sentì la necessità di considerare, per così dire, l’ambiente
naturale nella sua concezione più moderna e onnicomprensiva di tutti gli aspetti
biologici e naturalistici.
Da questa evoluzione si passò dal concetto di vincolo puramente paesaggistico a
quello di vincolo paesaggistico-ambientale, integrando il concetto di paesaggio
con quello di ambiente e habitat naturale. Terminologia quest’ultima che, pur
mantenendo l’immanenza semantica nel dettato normativo vigente, è comunque
venuta meno nel codice, rispetto al d.lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999,
preferendo il termine paesaggio al termine ambiente, per evitare confusioni
terminologiche o interferenze con altre norme riguardanti lo stesso ambito
normativo.
Come è noto, l’attuale disciplina di individuazione di un bene paesaggistico
prevede due ambiti di protezione paralleli ma distinti in relazione alle
procedure di individuazione.
In particolare, ci sono beni paesaggistici tutelati individualmente costituiti
attraverso un iter specifico che prevede la compilazione da parte della regione
di appositi elenchi su base provinciale finalizzati alla dichiarazione
preventiva e preliminare di notevole interesse pubblico (di cui alla citata
“legge Bottai” n. 1497 del 1939, ora articoli 136 e 138-141 del codice: cose
immobili con caratteri di bellezza naturale o singolarità geologica; ville,
parchi e giardini; complessi di cose immobili di valore estetico o tradizionale;
bellezze panoramiche considerate come quadri, punti di vista, belvedere) e beni
paesaggistici tutelati per legge - ope legis - (di cui alla “legge Galasso”, ora
articolo 142 del codice), ambedue comunque sottoposti allo stesso regime di
protezione.
Questi ultimi sussistono in modo automatico senza la necessità, in via generale,
di un provvedimento di individuazione specifico e selettivo, il quale invece è
previsto per il primo caso.
Tuttavia, anche per i beni tutelati per legge bisogna fare un ulteriore
distinguo, in quanto alcuni sono vincolati direttamente, in quanto aventi
requisiti naturalistici di comune e universale accertabilità (i territori
costieri e contermini ai laghi entro 300 metri dalla riva; le montagne per la
parte eccedente una determinata altitudine; i ghiacciai e i circhi glaciali; i
territori coperti da foreste e boschi; i vulcani), mentre altri sono comunque
individuati indirettamente dalla legge, dovendo di fatto prevedere un atto
formale della competente autorità, presupposto necessario alla instaurazione del
vincolo paesaggistico.
In tal senso, infatti, per i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua si prevede che
siano vincolati solo quelli iscritti negli appositi elenchi di cui al R.D. 11
dicembre 1933 n. 1775 (T.U. sulle acque); i parchi e le riserve nazionali o
regionali sono istituiti con appositi decreti presidenziali o ministeriali o
regionali; le aree assegnate alle università agrarie presuppongono un atto
amministrativo di assegnazione; le zone gravate dagli usi civici presuppongono
l’esistenza di uno dei modi di costituzione degli usi civici stessi, come l’uso
collettivo immemorabile, la concessione sovrana e i contratti fra universitates;
le zone umide sono quelle incluse nell’elenco di cui al DPR 13 marzo 1976, n.
448; le zone di interesse archeologico non possono essere che quelle individuate
dalle autorità amministrative competenti in materia.
In ogni caso, tutti i beni menzionati dall’articolo 142 del codice appena citati
secondo le due possibilità di individuazione, sono sottoposti per il loro
interesse paesaggistico alle disposizioni del codice, ma solo fino
all’approvazione del piano paesaggistico di cui all’articolo 156 del codice,
creando una dipendenza da un atto amministrativo di destinazione del territorio.
A dimostrazione del fatto che in materia ci sono ancora dei nodi irrisolti di
rilevante importanza, cito due esempi che indicano una direzione inequivocabile,
anche se per certi aspetti contraddittoria con la norma, relativamente alla
automatica sussistenza, in determinate fattispecie, del vincolo paesaggistico.
Il primo è una circolare del Ministero per i beni culturali ed ambientali del 31
agosto 1985, sul tema dei vincoli sorti secondo la “legge Galasso”, la quale
precisa che “tali vincoli agiscono ope legis e, pertanto, non richiedono nessun
provvedimento amministrativo di notifica dell’interesse ipso iure tutelato”.
Il secondo esempio, in linea con il primo, seppure di tutt’altra natura, si
riferisce alla sentenza 657/02 del Consiglio di Stato del 4 febbraio 2002 con la
quale si è stabilito che i fiumi ed i torrenti sono soggetti a tutela
paesaggistica di per sé stessi, a prescindere dall’iscrizione negli elenchi
delle acque pubbliche, determinando conseguentemente sicuri problemi
interpretativi.
Questo complesso e articolato meccanismo di individuazione di un bene
paesaggistico, dettato da una continua stratificazione legislativa peraltro
giustificata da una evoluzione del concetto di tutela del paesaggio, ha spesso
generato attriti, sovrapposizioni e confusioni tra le diverse autorità statali e
locali chiamate in causa. Situazione che ha inevitabilmente portato a un
generale svuotamento dell’intenzione del legislatore che voleva una gestione del
vincolo stesso attraverso una prassi autorizzativa precisa e circostanziata,
trasformata di fatto in un mero passaggio burocratico e formale.
Emblematico è il caso di specie analizzato attraverso la sentenza in commento
nella prima parte di questo contributo, la quale cerca di riportare l’iter di
individuazione di un bene paesaggistico nell’alveo normativo previsto dalla
norma, escludendo possibili meccanismi non previsti che, se nella pratica
potrebbero semplificare il complesso circuito di relazioni che devono
sussistere, di fatto vanno a incidere negativamente sulla primaria funzione che
la Repubblica Italiana ha l’obbligo di svolgere, ovvero quella di tutelare il
patrimonio culturale della nazione (costituito dall’insieme dei beni culturali e
dei beni paesaggistici - articolo 2 del codice -), secondo il principio
fondamentale esposto nell’articolo 9 della Costituzione Italiana.