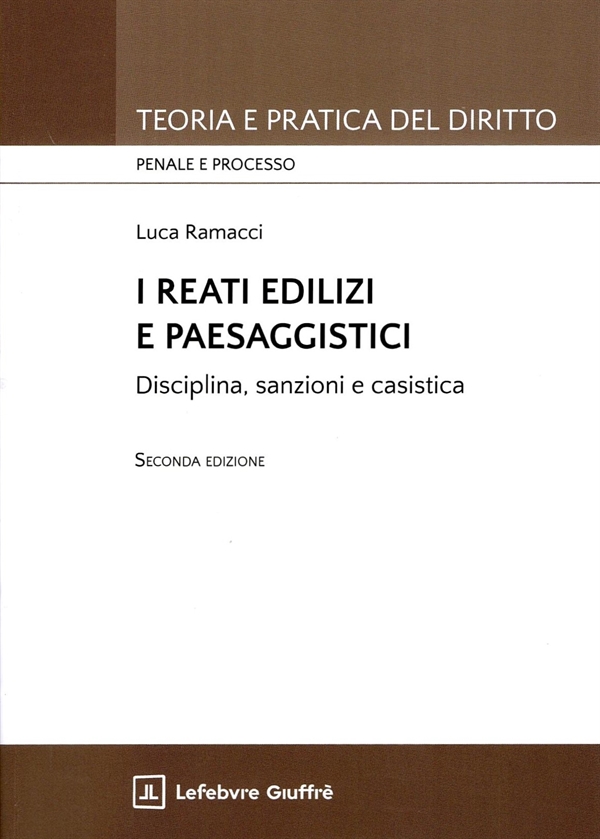Cass. Sez. III n. 5039 del 9 febbraio 2012 (Ud. 17 gen. 2012)
Cass. Sez. III n. 5039 del 9 febbraio 2012 (Ud. 17 gen. 2012)
Pres. Teresi Est. Ramacci Ric. Di Domenico
Rifiuti. Fertirrigazione
La pratica della “fertirrigazione”, la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, rispetto alla quale è autonoma ed indipendente e non richiede che gli effluenti provengano da attività agricola e siano riutilizzati nella stessa attività agricola, presuppone l'effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che essa sia di una qualche utilità per l'attività agronomica e lo stato, le condizioni e le modalità di utilizzazione delle sostanze compatibili con tale pratica, con la conseguenza che, in difetto, essa resta sottoposta alla disciplina generale sui rifiuti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/01/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 111/2012
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 28138/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI DOMENICO FRANCESCO N. IL 04/11/1974;
avverso la sentenza n. 567/2009 TRIBUNALE di MACERATA, del 30/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Macerata, con sentenza del 30 settembre 2010, riconosceva DI DOMENICO Francesco responsabile della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 2, per avere, quale titolare di azienda agricola destinata ad allevamento di bufale da latte, depositato in modo incontrollato sul terreno rifiuti speciali non pericolosi consistiti in letame, senza alcun sistema di contenimento e raccolta dei liquami derivanti da fenomeni di dilavamento, condannandolo alla pena dell'ammenda. Avverso tale pronuncia il predetto proponeva appello, convertito in ricorso per cassazione.
A sostegno del gravame, con un primo motivo, deduceva il vizio di motivazione, rilevando che il giudice, in maniera affrettata e con una indebita inversione dell'onere della prova, era pervenuto ad una affermazione di penale responsabilità escludendo la fondatezza della tesi difensiva secondo la quale le deiezioni animali provenienti dall'allevamento erano utilizzate per pratiche di fertirrigazione di terreni di proprietà dell'azienda.
Con un secondo motivo deduceva la violazione di legge, osservando che il Tribunale aveva errato nel considerare le deiezioni animali quali rifiuti speciali non pericolosi poiché, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, lett. e), dette sostanze erano sottratte alla disciplina dei rifiuti in quanto "rifiuti agricoli". Aggiungeva che la sua azienda svolgeva attività agricola e riutilizzava il letame su terreni di proprietà per la fertirrigazione nell'ambito, quindi, di normali pratiche agricole. Con un terzo motivo deduceva il vizio di motivazione, lamentando che il giudice del merito aveva erroneamente valutato le dichiarazioni rese dai testimoni escussi e la documentazione acquisita sull'accordo delle parti.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del gravame. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
Occorre preliminarmente ricordare che l'istituto della conversione della impugnazione, previsto dall'art. 568 c.p.p., comma 5, ed ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta. (Sez. 1 n. 2846, 9 luglio 1999 ed altre succ. conf.).
Da ciò consegue l'inammissibilità del terzo motivo di gravame, attraverso il quale viene proposta una lettura alternativa delle risultanze processuali, non consentita in questa sede di legittimità.
Invero, la consolidata giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano ad esempio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., dalla L. n. 46 del 2006, Sez. 6^ n. 10951, 29 marzo 2006; Sez. 6^ n. 14054, 20 aprile 2006; Sez. 6^ n. 23528, Sez. 3^ n. 12110, 19 marzo 2009).
Il primo e secondo motivo di gravame possono invece essere esaminati congiuntamente, rilevando che la loro infondatezza risulta di macroscopica evidenza.
Il Tribunale ha compiutamente indicato gli elementi fattuali sui quali viene fondata l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, titolare di un allevamento di bufale presso il quale personale del Corpo Forestale dello Stato rinveniva letame solido prelevato dalle vasche di raccolta depositato in modo incontrollato il quale, anche per effetto del dilavamento, confluiva attraverso diversi punti di immissione all'interno di un fosso. A fronte di tale ricostruzione dei fatti, il ricorrente deduce, in sintesi, che le deiezioni animali, escluse dal novero dei rifiuti, venivano raccolte in vasche a tenuta e che le quantità rinvenute in cumuli dovevano essere utilizzate per la fertirrigazione, pratica impedita dalle abbondanti piogge di quel periodo, causa anche del dilavamento.
Si deve dunque verificare, in primo luogo, se le menzionate sostanze rientrino o meno nel novero dei rifiuti e, successivamente, qualificare l'attività svolta dai ricorrenti.
L'allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, (così come, in precedenza, l'allegato A al previgente D.Lgs. n. 22 del 1997) indica tra i rifiuti, con il codice CER 02 01 06, "feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sitò".
In via generale ed in presenza delle condizioni richieste dalla vigente disciplina, dette sostanze sono rifiuti.
Tuttavia, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, pone alcuni limiti al campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, concernente la disciplina dei rifiuti, come già faceva l'articolo 8 dell'ormai abrogato D.Lgs. n. 22 del 1997.
Per quel che qui interessa, il menzionato art. 8 disponeva, al comma 1, lett. e) che erano esclusi dal campo di applicazione del decreto "le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione di fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli".
Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, nell'originaria formulazione, vigente fino al 12 febbraio 2008, escludeva, alla lett. e) "le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza".
L'art. 185 subiva, nel tempo, ben cinque modifiche e, all'epoca dei fatti (accertati il 6 marzo 2008), al comma 1, lett. b), n. 5, disponeva che non rientravano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, "in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria, le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola", specificando ulteriormente, al comma secondo, che "possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni dell'art. 183, comma 1, lett. p): materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas" (tale ultima esclusione era, peraltro, puramente eventuale poiché le sostanze indicate potevano rientrare tra i sottoprodotti possedendo non solo tutte le caratteristiche rigorosamente indicate dalla legge per tale tipologia, ma anche disponendo, contestualmente, degli ulteriori requisiti singolarmente indicati per ciascuna categoria tra quelle elencate).
Prescindendo dall'esaminare gli ulteriori interventi modificativi, occorre infine ricordare che, nella formulazione attualmente in vigore, la medesima disposizione stabilisce l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti, al comma 1, lett. f) di "materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana". Il richiamato comma 2, lett. b), a sua volta, contempla l'esclusione, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento dei "sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformali, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio".
Nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 205 del 2010, che ha apportato le ultime modifiche all'art. 185, viene richiamata l'attenzione, relativamente alle materie fecali, sulla distinzione tra il contenuto del comma 1, lett. f) e quello del comma 2, del medesimo articolo, lett. b), osservando come quest'ultimo riguardi i soli sottoprodotti di origine animale disciplinati dal menzionato Regolamento comunitario definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento con modalità tali da delimitarne l'ambito di applicazione. Da ciò consegue che, per le materie fecali, è attualmente necessaria una preventiva verifica finalizzata ad individuarne la collocazione entro i limiti fissati dal Regolamento 1774/02 che ne determinerebbe l'esclusione dal novero dei rifiuti ai sensi dell'art. 185, comma 2, lett. b) e, nel caso in cui non operi la citata disposizione comunitaria, alla ulteriore verifica della sussistenza dei presupposti per l'esclusione fissati dell'art. 185, comma 1, lett. f).
Dal confronto delle diverse formulazioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, emerge che è sempre costante nel tempo il riferimento alla provenienza, alle caratteristiche ed alla successiva utilizzazione delle materie fecali, cosicché, anche nel caso in esame, tali peculiarità risultano determinanti.
Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie, oggetto di esame da parte del giudice di prime cure è stata proprio la effettiva utilizzazione successiva del letame.
A tale proposito, viene fatto riferimento alla pratica della fertirrigazione, per la quale deve farsi riferimento ad altre disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Come ricordato anche in ricorso, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 112, (come, in precedenza, il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 38, ora abrogato) consente "... l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla L. 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2" previa comunicazione all'autorità competente ai sensi all'art. 75 del medesimo decreto.
Tale attività, in base a quanto disposto dal secondo comma del menzionato art. 112, è disciplinata dalle regioni sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con D.M. 7 aprile 2006, il Ministero delle Politiche agricole e forestali ha dettato "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 38". Il D.Lgs. n. 152 del 1999, al quale fa riferimento il predetto decreto ministeriale, è stato però abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 175, comma 1, lett. bb), entrato in vigore il 29 aprile 2006. Il D.M. 7 aprile 2006 sebbene emanato prima del 29 aprile 2006, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2006, assumendo vigenza dopo che la norma al quale si riferiva (D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 38) era ormai abrogata, ma il difetto di coordinamento può essere risolto alla luce di quanto disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 170, comma 11, il quale stabilisce, senza ulteriori specificazioni relative al momento dell'entrata in vigore, che "fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli alti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175".
Ciò posto occorre ricordare che, come si è già avuto modo di precisare (Sez. 3^ n. 38411, 9 ottobre 2008), le disposizioni in materia di fertirrigazione hanno una portata derogatoria più ampia rispetto a quella prevista dalla disciplina sui rifiuti, rispetto alla quale è autonoma ed indipendente e non richiede che gli effluenti provengano da attività agricola e siano riutilizzati nella stessa attività agricola. Va inoltre tenuto conto, a tale proposito, della circostanza che, nella nozione di effluente da allevamento di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, lett. v), non sono ricomprese le sole materie fecali, ma anche la miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato. In considerazione della natura e condizione delle sostanze oggetto della richiamata disposizione si è ulteriormente precisato che la fertirrigazione non deve necessariamente effettuarsi attraverso lo scarico diretto tramite condotta, in quanto la deroga all'ordinaria disciplina è condizionata alla sola effettiva utilizzazione agronomica degli effluenti, in qualunque modo questa avvenga. L'ampiezza della deroga si è, inoltre, rilevata anche in considerazione del fatto che essa include tutte le fasi della gestione degli effluenti, ivi comprese quelle, intermedie, del deposito e del trasporto delle sostanze, come si ricava dalla nozione stessa di utilizzazione agronomica, definita dalla lett. p) del menzionato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, come "la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute" (la precedente lettera o) definisce l'applicazione al terreno come "l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strali superficiali, iniezione, interramento").
Così sommariamente inquadrata la disciplina di settore, occorre puntualizzare un dato essenziale e determinante.
Presupposto imprescindibile per l'effettuazione della pratica della fertirrigazione è l'effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che l'attività sia di una qualche utilità per l'attività agronomica e lo stato, le condizioni e le modalità di utilizzazione delle sostanze compatibili con tale pratica.
In altre parole, deve trattarsi di un'attività la cui finalità sia effettivamente il recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti e non può risolversi nel mero smaltimento delle deiezioni animali.
Da ciò consegue la necessità che, in primo luogo, vi sia l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, la quantità e qualità degli effluenti sia adeguata al tipo di coltivazione, i tempi e le modalità di distribuzione siano compatibili ai fabbisogni delle colture e, in secondo luogo, che siano assenti dati fattuali sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta, effettuato a fine ciclo vegetativo, oppure senza tener conto delle capacità di assorbimento del terreno con conseguente ristagno. Per quanto riguarda il regime sanzionatorio applicabile, va osservato che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 5, prevede un'ipotesi di illecito amministrativo, salvo che il fatto costituisca reato, per l'ipotesi di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 170, comma 7, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 112, comma 2, mentre l'art. 137, comma 14, stabilisce l'applicazione della sanzione penale per l'effettuazione dell'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure in caso di inottemperanza al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività e, infine, per l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente. Da ciò consegue, come già rilevato (Sez. 3^ n. 38411, 9 ottobre 2008, cit.) che, stante la presenza, nell'articolo 133, della clausola che fa salva l'applicabilità della sanzione penale, l'irrogazione della sanzione amministrativa è consentita "...solo per quelle violazioni delle disposizioni regionali che non consistano nell'esercizio della utilizzazione agronomica fuori dei casi e delle procedure previste, o nell'inizio della attività senza previa comunicazione all'autorità competente, ovvero mila inottemperanza al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività". È appena il caso di precisare che la richiamata disciplina sanzionatoria presuppone, in ogni caso, lo svolgimento di un'attività effettivamente inquadrabile nella nozione di utilizzazione agronomica in precedenza delineata, come si ricava agevolmente dal tenore letterale della norma la quale, infatti, fa sempre riferimento a tale specifica attività, ancorché effettuata al di fuori dei casi e delle procedure stabilite, con la conseguenza che ogni altra condotta non rientrante nella richiamata tipologia andrà opportunamente collocata entro ambiti diversi, comprendenti anche specifiche ipotesi di reato, quali quelle previste in caso di illecita gestione di rifiuti.
Alla luce delle considerazioni dianzi esposte va pertanto affermato il principio secondo il quale la pratica della "fertirrigazione", la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, rispetto alla quale è autonoma ed indipendente e non richiede che gli effluenti provengano da attività agricola e siano riutilizzati nella stessa attività agricola, presuppone l'effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che essa sia di una qualche utilità per l'attività agronomica e lo stato, le condizioni e le modalità di utilizzazione delle sostanze compatibili con tale pratica, con la conseguenza che, in difetto, essa resta sottoposta alla disciplina generale sui rifiuti.
In considerazione dei dati fattuali scrutinati dal giudice del merito e delle disposizioni in precedenza richiamate la decisione impugnata risulta corretta, poiché risulta del tutto mancante la prova dell'applicabilità, nella fattispecie, tanto della deroga prevista per le materie fecali dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, quanto di quella prevista dalla disciplina della pratica della fertirrigazione. Non vi è stato peraltro, da parte del giudice, alcuna indebita inversione dell'onere della prova, poiché tanto l'art. 185, quanto le disposizioni in tema di fertirrigazione, presuppongono l'applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali in tema di rifiuti e, come tali, impongono a chi l'invoca l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per la loro applicazione (si vedano, ad esempio, con riferimento a disposizioni diverse Sez. 3^ n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. 3^ n. 35138, 10 settembre 2009; Sez. 3^ n. 37280, 1 ottobre 2008; Sez. 3^ n. 9794, 8 marzo 2007; Sez. 3^ n. 21587, 17 marzo 2004;. Sez. 3^ n. 30647, 15 giugno 2004).
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00 tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012