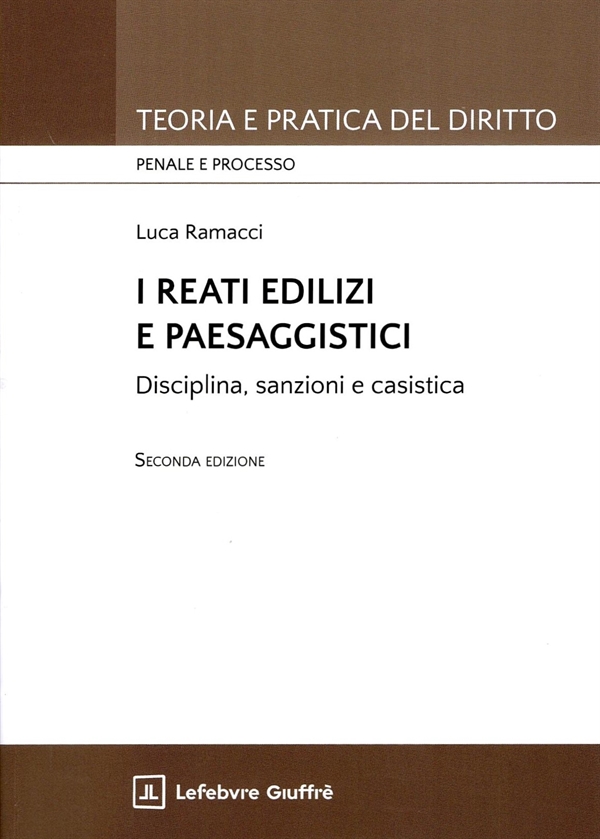Nuove sanzioni per l’illecita gestione rifiuti: considerazioni critiche al D.L. 116/2025 come convertito dalla L. 147/25.
Nuove sanzioni per l’illecita gestione rifiuti: considerazioni critiche al D.L. 116/2025 come convertito dalla L. 147/25.
di Stefano MAGLIA e Alessandra CORRU'
pubblicato su tuttoamboiente.it. Si ringraziano Autori ed Editore
E’ dunque in vigore dall’8 ottobre 2025, la Legge 3 ottobre 2025, n. 147 , che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”(c.d. D.L. Terra dei fuochi), che rappresenta una svolta storica nella disciplina degli illeciti ambientali , con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti.
Già a partire dal 9 agosto 2025 1 - data di entrata in vigore del citato decreto-legge - l’impossibilità di comprovare la regolarità di un deposito temporaneo, la mancata verifica delle autorizzazioni dei trasportatori o dei destinatari dei propri rifiuti, così come l’abbandono di rifiuti pericolosi o la loro spedizione illecita, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella propria autorizzazione, sono diventati delitti punibili con la reclusione.
L’intervento normativo non si limita ad apportare modifiche puntuali, ma riscrive in profondità l’assetto sanzionatorio contenuto nel D.L.vo 152/2006, nel Codice penale e nel D.L.vo 231/2001, con l’obiettivo dichiarato di contrastare con maggiore efficacia i fenomeni illeciti, spesso riconducibili ad attività imprenditoriali o criminali organizzate. Dubbi sulla sua efficacia – da un lato – e sulla proporzionalità di tali sanzioni rispetto alle singole fattispecie sono già stati giustamente sottolineati dalla dottrina2.
Il provvedimento in esame, come già si evinceva dalla Presentazione del ddl alla Camera in data 8 agosto 2025, nasce da una duplice esigenza: in primis, reprimere più efficacemente le attività illecite in materia di rifiuti , fenomeno in costante crescita, che non interessa più soltanto le aree tradizionalmente problematiche come la cosiddetta “ Terra dei fuochi”, ma si estende ormai a vaste aree del territorio nazionale. In secondo luogo, l’intervento normativo trova fondamento nella necessità di corrispondere a quanto richiesto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025, e in particolare dal Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d’Europa (COE), al quale l’Italia deve presentare entro settembre 2025 un Piano d’azione, tenendo conto della Direttiva UE 2024/1203 sulla Tutela penale dell’ambiente.
In particolare, in un’ottica decisamente repressiva, il legislatore inasprisce il trattamento sanzionatorio relativo a diverse fattispecie di reato come l’abbandono rifiuti e la gestione non autorizzata, ora trasformati in delitti punibili con la reclusione.
Questo “slittamento” da contravvenzioni a delitti, parzialmente limitato con la L. 147/25, fa sì che in tutti questi casi non si potrebbero più applicare né l’istituto dell’ oblazione (artt.162 e 162-bis del Codice Penale) né la procedura della parte VI bis del D.L.vo 152/2006, né quella della tenuità del fatto che avrebbero prodotto – fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge – l’estinzione del reato. Non solo: divenendo reati gravi diventa decisamente più agevole utilizzare strumenti di indagine ben più “invasivi” ed efficaci, per esempio le intercettazioni telefoniche, arresto in flagranza differita o operazioni sotto copertura (artt. 266 e 267 Cod. proc. pen.).
Sul fatto che, nello specifico, in questo modo si produca - dall’altro lato - un oggettivo ulteriore depotenziamento dell’istituto ex art. 318-bis e ss. del D.L.vo 152/2006, con “sicuro affaticamento dei Tribunali”, si concorda con chi ha già sollevato tale criticità3.
La trasformazione degli illeciti in delitti determinerà infatti inevitabilmente un incremento del carico giudiziario, senza dimenticare che, in considerazione del fatto che i termini di prescrizione si sono allungati in virtù della nuova qualificazione degli illeciti come delitti e non più come contravvenzioni, è ragionevole attendersi che la difesa degli imputati ricorrerà sistematicamente a questo strumento di impugnazione, anche solo nella prospettiva di giungere, prima o poi, alla prescrizione del reato, resa sempre più probabile dal progressivo congestionamento degli uffici giudiziari4.
Tutto quanto premesso, di seguito ci si appresta a sintetizzare le principali novità introdotte dal provvedimento, così come convertito in Legge, al precedente quadro sanzionatorio in materia di rifiuti, partendo proprio dalle modifiche apportate al D.L.vo 152/2006 (art. 1).
Al fine di disincentivare condotte illecite da parte di imprese che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, all’art. 212 del D.L.vo 152/2006 viene aggiunto il comma 19-ter che prevede una sanzione accessoria per tali imprese che, pur dovendo, non risultino iscritte all’Albo e commettano illeciti in materia di rifiuti. Oltre alle sanzioni specifiche per ogni violazione (es. abbandono di rifiuti, gestione non autorizzata di rifiuti, etc.), è prevista la sospensione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi da 15 giorni a 2 mesi. In caso di reiterazione o recidiva, scatta la cancellazione da tale Albo con divieto di reiscrizione per 2 anni.
Il legislatore ha poi riorganizzato l’intera disciplina relativa all’abbandono dei rifiuti, distinguendo tre ipotesi principali.
La prima riguarda l’abbandono di rifiuti non pericolosicommesso da chiunque, punito dall’ art. 255.
Si tratta ancora di una contravvenzione, ma con pene più severe rispetto al passato: l’ammenda è stata infatti innalzata e va ora da 1.500 a 18.000 euro. Inoltre, se l’abbandono o il deposito avvengono mediante l’uso di un veicolo a motore, al conducente viene applicata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che varia da 4 a 6 mesi.
Più gravi sono le conseguenze quando l’abbandono di rifiuti non pericolosi è posto in essere da titolari di imprese o responsabili di enti. In questo caso, la condotta continua a essere qualificata come contravvenzione, ma è punita con l’arresto da 6 mesi a 2 anni o un’ammenda da 3.000 a 27.000 euro. Questa previsione sostituisce la precedente norma contenuta nell’articolo 256, comma 2, che viene contestualmente abrogata.
All’interno dell’art. 255 è stata poi modificata la sanzione amministrativa, da 80 a 320 euro, per l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, come mozziconi di sigaretta, scontrini, fazzoletti o gomme da masticare. In sede di conversione del decreto-legge, è stata altresì introdotta, sempre all’interno dell’art. 255, la sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro per chi abbandona
rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade, con relativa sanzione accessoria di fermo del veicolo per un mese.
Il legislatore ha poi introdotto un’ulteriore fattispecie con l’art. 255-bis (“Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari”), che eleva a delitto l’abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi che comporti pericolo per persone o ambiente, o avvenga in siti contaminati. La pena è la reclusione da 6 mesi a 5 anni, aumentata se l’autore è un’impresa o un ente, con sospensione della patente da 2 a 6 mesi in caso di utilizzo di veicoli.
Infine, l’art. 255-terdisciplina l’abbandono di rifiuti pericolosi,punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La pena sale fino a 6 anni di reclusione in caso di pericolo per la salute o l’ambiente, con ulteriori aggravamenti se il reato è commesso da imprese o enti: in tal caso, la reclusione prevista è da 1 a 5 anni e 6 mesi per l’abbandono semplice, e da 2 a 6 anni e 6 mesi se sussistono i pericoli o le circostanze aggravanti sopra indicate.
Anche in sede di conversione, si evidenzia peraltro una grave anomalia, ovvero che il comma 3 dell’art. 192 del D.L.vo 152/2006 è rimasto invariato,producendo una incoerente ed ingiustificabile situazione. Si rammenta che, nella sua formulazione attualmente vigente, esso infatti così dispone: “3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie e il termine entro cui provvedere; decorso tale termine, procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.”
Dalla lettura della norma emerge chiaramente l’esigenza di un coordinamento con i nuovi delitti introdotti dagli artt. 255-bis e 255-ter. Tale coordinamento risulta indispensabile poiché, allo stato attuale, la disposizione potrebbe generare un effetto paradossale: chi abbandona rifiuti non pericolosi in casi particolari o rifiuti pericolosi non risulterebbe, di fatto, obbligato alla rimozione degli stessi e al ripristino dello stato dei luoghi, cosa rimasta invece ancora vigente per quanto riguarda l’abbandono di rifiuti non pericolosi!
L’art. 256,che disciplina l’attività di gestione non autorizzata dei rifiuti, è stato oggetto di importantissime modifiche a seguito della conversione in Legge.
Nel testo originario del decreto-legge il legislatore aveva previsto la trasformazione in delitto di tutte le ipotesi di gestione non autorizzata di rifiuti. Con la legge di conversione, invece, è stata operata una distinzione: la gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi torna ad essere una contravvenzione,peraltro oblabile ed alla quale rimane quindi applicabile la Parte VIbis del D.L.vo 152/2006, in quanto punita con la pena dell’arresto da 3 mesi a 1 anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, mentre la gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi rimane qualificata come delitto, punita con la reclusione da 1 a 5 anni.
Tutto ciò induce ad almeno due riflessioni: la prima è relativa alla sempre più fondamentale importanza della corretta classificazione dei rifiuti (in particolare in caso di voci a specchio), la seconda fa invece riferimento a tutte le ipotesi di responsabilità estesa del produttore di cui alla ormai consolidata giurisprudenza5.
Il trattamento sanzionatorio è poi ancora più severo quando dalla gestione illecita derivano pericoli per la vita o l’incolumità delle persone, o quando il fatto è commesso in “siti contaminati” genericamente intesi. In questi casi, se i rifiuti sono non pericolosi, la pena è la reclusione da 1 a 5 anni; se sono pericolosi, la pena è la reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi.
Inoltre, se le violazioni dell’art. 256 sono commesse mediante l’uso di un veicolo, al conducente si applica la sospensione della patente da 3 a 9 mesi; alla condanna o al patteggiamento per gestione non autorizzata consegue la confisca del mezzo utilizzato, salvo che appartenga a un soggetto estraneo al reato.
Il legislatore, in sede di conversione del decreto in legge, non ha invece colto l’occasione per accogliere i numerosi emendamenti proposti volti alla soppressione dell’assurda e controversa figura del produttore giuridico del rifiuto, che continua pertanto a permanere nel nostro ordinamento, con tutte le note criticità interpretative e applicative che ne derivano6.
Anche il reato di discarica non autorizzata subisce un inasprimento, passando da contravvenzione a delitto. L’art. 256, comma 3, stabilisce che chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Se la discarica è destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi.
Quando dalla discarica deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, o danno all’ambiente, le pene si aggravano ulteriormente: reclusione da 2 a 6 anni, che diventa da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se vi sono coinvolti anche rifiuti pericolosi.
In sede di conversione del decreto-legge, è stato fortunatamente modificato - ma non a sufficienza -anche il comma 4 dell’art. 256 che, nella versione precedente alla conversione7, prevedeva una sanzione assolutamente sproporzionata rimanendo agganciato al comma 1 dell’art. 256 andando a configurare un delitto per una mera inottemperanza di prescrizioni8 .
Ora9, invece, il legislatore punisce con l’ammenda da 6.000 a 52.000 euro o con l’arresto fino a 3 anni (contravvenzione oblabile)colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, non ne osservi le prescrizioni contenute, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi o quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)10, sanzione comunque ancora sproporzionata non solo relativamente al fatto che trattasi di precetti di natura amministrativa, ma anche in relazione alle sanzioni previste per inadempimento prescrizionale, per esempio nella disciplina di cui alle Parti II, III e V del D.L.vo 152/2006.
E i rifiuti pericolosi? Quando si parla di inosservanza di prescrizioni, il legislatore pare essersi “distrattamente” dimenticato di loro o comunque l’attuale formulazione della disposizione è tutt’altro che chiara…
Infine, per quanto riguarda il reato di miscelazione non autorizzata previsto dal comma 5 dell’art. 256, la legge di conversione ha confermato incomprensibilmente la natura contravvenzionale della sanzione, trasformandola addirittura in pena alternativa e quindi oblabile : “arresto da sei mesi a due anni o ammenda da 2.600 a 26.000 euro”.A riguardo, si cita l’art. 187del D.L.vo 152/2006 che dispone chiaramente che:“1.E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi . La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.”.
Appare quindi legittimo domandarsi come una condotta di tale gravità, che riguarda direttamente i rifiuti pericolosi, possa essere ancora qualificata come contravvenzione, anziché come delitto.
Il reato di combustione illecita di cui all’art. 256-bis, comma 1 (c.d. “ Terra dei fuochi”) resta un delitto punito con la reclusioneda 2 a 5 anni, pena che sale da 3 a 6 anni se i rifiuti sono pericolosi.
Il comma 2 è stato invece modificato, collegando la combustione illecita ad altri reati previsti dal D.L.vo 152/2006: oggi le stesse pene del comma 1 si applicano anche a chi abbandona rifiuti (art. 255, commi 1 e 1.1) in funzione della successiva combustione.
Con il nuovo comma 3-bis viene poi introdotto un ulteriore aggravamento: se dalla combustione di rifiuti non pericolosi deriva pericolo per la vita delle persone o l’ambiente, la pena è la reclusione da 3 a 6 anni, che aumenta da 3 anni e 6 mesi a 7 anni in caso di rifiuti pericolosi.
È prevista, infine, una specifica aggravante: se la combustione illecita provoca un incendio, le pene sono aumentate fino alla metà.
Se uno degli obiettivi prioritari di questo D.L. era quello di rendere più efficace la lotta alla “Terra dei fuochi”,non si ravvedono in realtà particolari novità rispetto alla disciplina precedente11.
L’art. 258è stato modificato con un inasprimento delle sanzioni che rimangono comunque ancora amministrative. Oggi la mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro. Con il nuovo comma 2-bis è stabilito inoltre che a tale violazione si accompagna sempre una sanzione accessoria: la sospensione della patente da 1 a 4 mesi per i rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi per i pericolosi; consegue altresì la sospensione dall’Albo Gestori Ambientali da 2 a 6 mesi (non pericolosi) o da 4 a 12 mesi (pericolosi).
Modificato anche il comma 4, relativo a chi trasporta rifiuti pericolosi senza formulario , che non rimanda più all’art. 483 Cod. Pen., ma ne ipotizza comunque sostanzialmente la medesima sanzione della reclusione da 1 a 3 anni12 .La stessa pena si applica a chi predispone certificati di analisi falsi o li utilizza durante il trasporto. In questi casi, alla condanna o al patteggiamento consegue la confisca del mezzo utilizzato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
Il reato di “traffico illecito” – previsto e punito dall’art. 259 -viene finalmente rubricato in modo corretto “spedizione illegale di rifiuti”, superando l’ambiguità che in passato generava confusione con il distinto reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. ed armonizzandolo con le disposizioni del nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
La pena base è la reclusione da 1 a 5 anni, aumentata per i rifiuti pericolosi.
Il nuovo art. 259-bis introduce una aggravante speciale per i delitti di cui agli articoli 256, 256-bis e 259 del D.L.vo 152/2006 (gestione non autorizzata di rifiuti, combustione illecita e spedizione illegale di rifiuti). Quando tali reati sono commessi nell’ambito di un’impresa o comunque di un’attività organizzata, le pene previste vengono aumentate di un terzo. Con la conversione in legge viene invece abrogata la disposizione, sempre all’interno dell’art. 259-bis, che prevedeva che il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività dovesse sempre rispondere anche per omessa vigilanza sugli autori materiali del reato riconducibili all’impresa o all’attività stessa.
Un’ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione dei delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter). La disposizione prevede che, se i fatti disciplinati dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 vengono commessi per colpa, le pene stabilite per tali reati siano ridotte da un terzo a due terzi.
Si segnala che con la conversione in legge viene introdotto il nuovo art. 1-bis che reca modifiche al D.L.vo 14 marzo 2014, n. 49 , al fine di contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti e intercettare maggiori quantità di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche . In particolare, all’art. 11, comma 1, viene precisato che, contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell’acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici, a titolo gratuito e senza che vi sia l’obbligo di acquistare una nuova apparecchiatura equivalente.
Un’ulteriore modifica riguarda l’articolo 38: dopo il comma 1 sono stati inseriti due nuovi commi. Con il comma 1-bis si stabilisce che, qualora il distributore ometta di comunicare, tramite il portale telematico predisposto dal Centro di Coordinamento, i luoghi in cui avviene il deposito preliminare alla raccolta è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Con il comma 1-ter, invece, si precisa che la violazione da parte del distributore degli obblighi previsti dall’art. 34, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000 a 10.000 euro.
Il nuovo provvedimento interviene anche sul Codice penale (art. 2) , nello specifico:
- sull’art. 131-bis,stabilendo che l’istituto della particolare tenuità del fattonon può essere applicato ai delitti, consumati o tentati, in materia di rifiuti previsti dagli articoli 255-ter, 256 (commi 1-bis, 3 e 3-bis), 256-bis e 259 del D.L.vo 152/2006;
- sull’art. 452-sexies ( “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”) che prevede la reclusione da 2 a 6 anni e una multa da 10.000 a 50.000 euro per chiunque, senza titolo, ceda, acquisti, trasporti, importi, esporti, detenga, trasferisca, abbandoni o comunque si disfi in modo illecito di materiale ad alta radioattività. Con la nuova modifica, la pena è aumentata fino alla metà quando dal fatto derivi un pericolo per la vita, l’incolumità pubblica o l’ambiente;
- sull’art. 452-quaterdecies(“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”)che punisce con la reclusione da 1 a 6 anni chiunque, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto, gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti tramite più operazioni e con l’allestimento di mezzi e attività organizzate in modo continuativo. La nuova formulazione specifica che le pene devono essere aumentate fino alla metà qualora la condotta comporti pericolo per la vita, l’incolumità pubblica o l’ambiente.
Una rilevante novità è rappresentata, con la conversione in Legge, dall’introduzione del nuovo art. 2-bis che reca tutta una serie di pene accessorie per le persone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, che, per un periodo non inferiore ad 1 anno né superiore a 5 anni, non potranno ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio, concessioni di acque pubbliche, contributi, finanziamenti o mutui per lo svolgimento di attività imprenditoriali, etc.
Vengono invece confermate le modifiche:
- all’art. 382-bis del codice di procedura penaleal fine di rendere applicabile l’istituto dell’ arresto in flagranza differita ad una serie di reati, di significativo disvalore penale, diretti a tutelare il bene giuridico “ambiente” (art. 3);
- all’art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146,che amplia il novero dei reati cui può applicarsi l’istituto della tecnica investigativa speciale delle operazioni sotto copertura, venendo così ad includere tutte quelle ipotesi di illecito ambientale già esaminati poco sopra, tra cui all’art. 256, comma 1, D.L.vo 152/2006 (art. 4);
- all’art. 34 del codice delle leggi antimafiache estende il catalogo di reati per i quali può essere disposta la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, includendovi pure alcune ipotesi di illeciti penali in materia di rifiuti (art. 5).
Il decreto-legge convertito in Legge (art. 6) conferma, altresì, l’aumento delle pene di natura amministrativa pecuniaria connesse ai reati ambientali presupposto per il riconoscimento della responsabilità degli enti, come stabilito nell’elenco ricompreso nell’art. 25-udecies del D.L.vo 231/2001.In particolare, vengono aumentate le pene previste per gli enti - definite da un sistema di “quote” - in relazione ai reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica e i nuovi reati di abbandono di rifiuti, gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti e spedizione illegale di rifiuti.
Fra le novità si segnala che l’art. 25-undecies dispone che, qualora l’ente o la sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis), disastro ambientale (art. 452-quater), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256), combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) e 259 (spedizione illegale di rifiuti) e inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 del D.L.vo 202/2007), si applichi la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività13 .
In riferimento alle modifiche apportate al Codice della strada (art. 7) , peraltro tutte confermate in sede di conversione, si richiama anche la Circolare n. 59513 del 10 settembre 2025 con la quale il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti sul campo di applicazione della nuova lett. f-bis) aggiunta all’art. 15 - che disciplina le ipotesi di getto o deposito sulle strade o loro pertinenze di rifiuti di cui agli artt. 232-bis e 232-ter del D.L.vo 152/2006 (rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni), dai veicoli in sosta o in movimento - e dell’art. 255, comma 1-bis, del D.L.vo 152/2006.
Con la conversione in legge vengono confermati i contenuti degli artt. 8 (“Utilizzo della Carta nazionale dell’uso del suolo dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura” ), 9 (“Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi”), 10 (“ Misure urgenti per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi”) e 11 (“Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche”), che riguardano prevalentemente misure economiche, e viene aggiunto un nuovo art. 9-bis (“Misure per rafforzare lo sviluppo del Mezzogiorno”) , con riferimento al quale, almeno in una prima lettura, non è affatto chiara la portata e l’attinenza di questo nuovo “Dipartimento per il Sud” con le finalità del D.L. 116.
In conclusione, la conversione in Legge del 116/2025 parrebbe segnare dunque il passaggio ad una fase di “tolleranza zero” nei confronti dei più gravi illeciti ambientali. Oggi infatti le condotte di abbandono, gestione non autorizzata, spedizione illegale o combustione di rifiuti espongono le Aziende a conseguenze penali più gravi, indagini invasive e sanzioni interdittive estremamente gravose per la stessa continuità aziendale.
La prevenzione, la formazione e il monitoraggio costante delle procedure diventano quindi imprescindibili. Non si tratta solo di “evitare la multa”: il rischio concreto è quello di compromettere la vita dell’impresa, la libertà personale dei suoi gestori e, non ultimo, la tutela della salute e dell’ambiente.
Il messaggio del Legislatore è inequivocabile e condivisibile: la prevenzione ambientale non è più un’opzione , ma un obbligo giuridico e organizzativo, ma tutto ciò deve essere necessariamente inserito nel solco dei principi fondamentali che regolano il sistema repressivo penale ambientale alla luce della Dir. UE 1998/99, recentemente sostituita dalla Dir. UE 2024/1203 sulla “Tutela penale dell’ambiente”, direttiva che dovrà essere recepita anche nel nostro Paese entro maggio prossimo14.
Ricordiamo in proposito che sia nei Considerando (punto 4) che nel dispositivo (art. 5) si sottolinei con forza che le sanzioni “devono essere effettive, proporzionate e dissuasive ”.
Con questo provvedimento siamo certi che siano stati rispettati questi fondamentali principi?
Personalmente ho molti dubbi, in particolare sulla proporzionalità.
E’ da sperare che il decreto legislativo che dovrà recepire la Direttiva UE 2024/1203 entro pochi mesi ristabilirà tali priorità.
In ogni caso un fatto è certo: d’ora innanzi il non riuscire a dimostrare di aver fatto tutto il possibile15 per ottemperare alla corretta gestione dei rifiuti, identificare con certezza cosa è un rifiuto o un non rifiuto (es. sottoprodotti), se è pericoloso o non pericoloso e se abbiamo controllato le autorizzazioni dei trasportatori e destinatari dei nostri rifiuti, costerà carissimo.
Non c’è più spazio per gli ecofurbi e gli ecoignoranti.
Ma che sia chiaro: nulla da eccepire sulla ratio di offrire strumenti più efficaci e dissuasivi per la lotta alle più gravi e sostanziali infrazioni ambientali, ma in questo provvedimento ci sono troppe incongruenze e messaggi contradditori che rischiano di produrre più confusione che vantaggi.
1 S. MAGLIA, “Prime osservazioni al DL 116/25 sui reati in materia di rifiuti”, articolo consultabile su www.tuttoambiente.it
2 G. AMENDOLA, “Il decreto legge n. 116/25 sulla Terra dei fuochi”, articolo consultabile su lexambiente.it, e
V. PAONE, “Le modifiche in materia di reati connessi alle illegalità nel settore dei rifiuti servono veramente a tutelare l’ambiente? ”, articolo consultabile su lexambiente.it
3 V. PAONE, op.cit. Sul punto si veda anche C. RUGA RIVA, “Il c.d. decreto terra dei fuochi sui rifiuti: tra Greta, Dracone e Tafazzi”, in Sistema penale 9/2025.
4 V. PAONE, op.cit.
5 S. MAGLIA, “Responsabilità e controllo formale delle autorizzazioni in materia di rifiuti”, articolo consultabile sul sito www.tuttoambiente.it
Sul punto si vedano anche :
- Cass. Pen. Sez. III, n. 20734 del 27 maggio 2022: “Nel settore dei rifiuti vige il principio, sotteso all'esigenza di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente di diretta derivazione dalla normativa comunitaria basata sulla regola del "chi inquina paga", della "responsabilità condivisa" e della vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti, sancito dal combinato disposto degli artt. 178 e 188 D.L.vo 152/2006, che grava su tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nel ciclo della gestione dei rifiuti, comprensivo di tutte le attività di produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, e che si estende al di là della sfera di operatività della condotta del singolo, chiamato a rispondere per omesso controllo anche dell'operato di tutti i soggetti le cui condotte si intersechino con la propria.”
- Cass. Pen. Sez. III n. 33144 del 27 agosto 2024: “In tema di gestione dei rifiuti, l’affidamento degli stessi a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta, per colui che li conferisca, precisi obblighi di accertamento tra cui, in particolare, la verifica dell’esistenza in capo ai medesimi delle necessarie autorizzazioni e competenze per l’espletamento dell’incarico, secondo il principio di cui all’art. 178 del d.lgs. 152/2006. La violazione di tali obblighi giustifica l’affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo”.
6 S. MAGLIA, “ Rifiuti: facciamo il punto sul produttore giuridico!”, articolo consultabile sul sito www.tuttoambiente.it
7 Art. 256, D.L.vo 152/2006:
“ 4. Le pene di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni”.
8 S. MAGLIA, op. cit.
9 Art. 256, D.L.vo 152/2006:
“ 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell’arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)”.
10 Art. 256, D.L.vo 152/2006:
“1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.”
11 S. MAGLIA, “Terra dei fuochi o dei cuochi?”,Editoriale del 30 settembre 2025, consultabile sul sito www.tuttoambiente.it
12 S. MAGLIA, op. cit.
13 F. SALMI, B. D’AQUINO, “ Il D.L. 116/25 e le modifiche all’art. 25undecies del Decreto legislativo 231/2001”, articolo consultabile sul sito www.tuttoambiente.it
14 S. MAGLIA, “La Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente: prime osservazioni”, articolo consultabile sul sito www.tuttoambiente.it
15 S. MAGLIA, “ Gestione ambientale corretta: è obbligatorio dimostrare di aver fatto tutto il possibile”, articolo consultabile sul sito www.tuttoambiente.it
Sul punto si veda anche Cass. 27148/23: “Le Sezioni Unite della Corte, hanno precisato altresì che il dovere di informazione non va valutato “in astratto”, bensì in relazione all’attività svolta dal soggetto che allega la scusabilità dell’ignoranza, sussistendo in relazione all’attività svolta il preciso dovere giuridico di conoscere le disposizioni di legge e della (tecnica che la regolano articolo 43 c.p.). Per l’effetto, mentre per il comune cittadino l’inevitabilità dell’errore va riconosciuta ogniqualvolta l’agente abbia assolto, con il criterio dell’ordinanza diligenza, al cosiddetto “dovere di informazione” attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, per coloro che svolgano professionalmente una determinata attività tale obbligo di informazione è particolarmente rigoroso, tanto che essi rispondono dell’illecito anche in virtù della culpa levis nello svolgimento dell’indagine giuridica. Con riferimento alla gestione di rifiuti, la corte ha inoltre precisato che “in tema di illecita gestione di rifiuti si deve escludere l’ipotesi della buona fede quando la fallace interpretazione del contenuto della autorizzazione e la erronea convinzione di possedere un titolo legittimante è dovuta ad un comportamento colposo poiché in tal caso l’imputato è venuto meno al dovere, che grava sui privati che svolgono in modo professionale attività normativamente regolate, di accertare con diligenza quale sia la disciplinata del settore”.