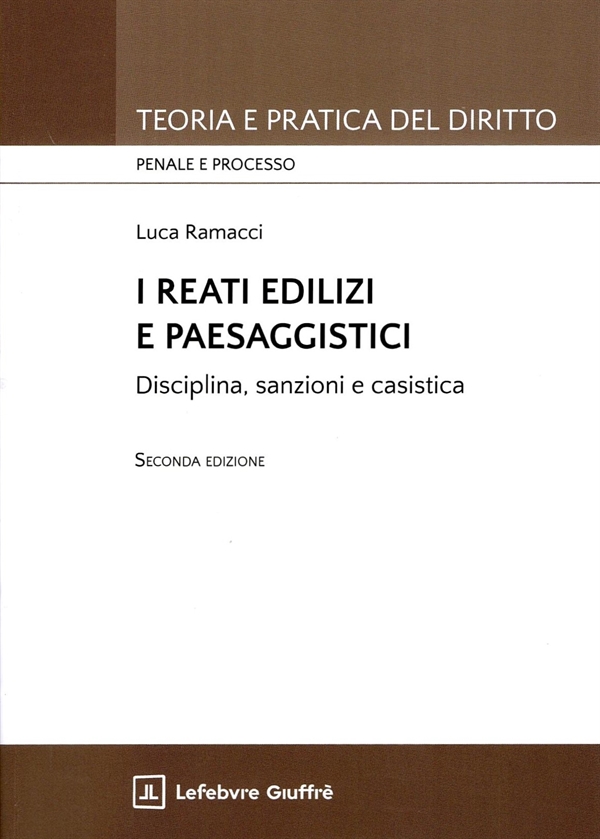Cass. Sez. III n. 27715 del 16 luglio 2010 (Cc 20 mag. 2010)
Cass. Sez. III n. 27715 del 16 luglio 2010 (Cc 20 mag. 2010)
Pres. Onorato Est. Franco Ric. Barbano
Urbanistica. Piano urbanistico
Il piano urbanistico generale, al pari di tutti gli atti amministrativi, è atto tipico e soggetto al principio di legalità, secondo il quale i provvedimenti amministrativi sono a numero chiuso ed hanno contenuti predeterminati dalla legge. D’altra parte, i piani regolatori sono per loro natura atti amministrativi generali a contenuto non provvedimentale ma normativo, cioè connotati dalla presenza di regole generali, e non da progetti architettonici. Il che conferma che un progetto approvato in variante non diventa per intero regola di piano, ma comporta soltanto l’integrazione del piano con la specifica variante richiesta su di esso dal progetto. Da ciò poi deriva che successive varianti al progetto comporteranno una nuova modifica al piano e richiederanno quindi una nuova variante al piano con la procedura concertativa non già se esse abbiano carattere «sostanziale» o «essenziale» rispetto al progetto (circostanza questa irrilevante ai fini che qui interessano) bensì qualora abbiano incidenza su quella specifica parte di piano la cui integrazione si era resa necessaria per l’approvazione del progetto originario (ovvero, ovviamente, su altre norme del piano)
UDIENZA del 20.05.2010
SENTENZA N. 802
REG. GENERALE N. 576/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Pierluigi Onorato Presidente
2. Dott. Agostino Cordova Consigliere
3. Dott. Aldo Fiale Consigliere
4. Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
5. Dott. Luigi Marini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da Barbano Fabrizio;
- avverso l'ordinanza emessa il 25.11.2009 dal tribunale del riesame di Savona;
- udita nella udienza in camera di consiglio del 20 maggio 2010 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
- udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
- udito il difensore avv. Paolo Gaggero;
Svolgimento del processo
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Savona confermò il provvedimento 4.11.2009 del GIP di Savona che aveva disposto il sequestro preventivo di un cantiere e di un complesso immobiliare in relazione al reato di cui all'art. 44, lett. c), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, perché realizzato senza un legittimo titolo edilizio. In particolare, secondo l'accusa, la proprietaria aveva ottenuto il 16.12.2005 un legittimo permesso di costruire con approvazione del progetto edilizio di variante allo strumento urbanistico a seguito della procedura concertativa con indizione della conferenza di servizi prevista dalla legge regionale, con la quale era stata autorizzata la demolizione e ricostruzione non fedele dell'opera. In seguito però erano stati rilasciati due ulteriori permessi di costruire relativi a varianti essenziali senza l'attivazione della procedura concertativa (assenso del consiglio comunale e conferenza di servizi) prevista per le varianti allo strumento urbanistico generale; ed inoltre era stato approvato un progetto nel cui volume complessivo non erano stati computati numerosi vani posti ai piani cantine e ai piani abitabili, denominati piani tecnici o pertinenze o cantine.
Osservò il tribunale del riesame:
- che il suo compito era limitato alla verifica della astratta possibilità di sussumere il fatto in una ipotesi di reato;
- che nella specie non emergeva la manifesta infondatezza della ipotesi di accusa;
- che infatti era astrattamente sostenibile che i due successivi progetti che recavano varianti essenziali al progetto iniziale dovessero essere approvati non con il solo permesso di costruire ma con una nuova procedura concertativa, come quella con la quale era stato approvato il progetto iniziale, dato che si era trattato di variazioni essenziali e sostanziali;
- che il tribunale non poteva assolutamente entrare nel merito della ipotizzata creazione di volumi non consentiti.
L'indagato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 324 cod. proc. pen. Lamenta che il tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto che il suo compito fosse limitato ad accertare la astratta configurabilità del reato ed ha quindi omesso ogni verifica sulla sussistenza del fumus del reato ipotizzato. Manca ogni esame ed ogni motivazione sulle osservazioni della difesa sulla correttezza della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio, sulla irrilevanza di eventuali irregolarità procedurali in rapporto alla legittimità sostanziale dell'atto, e sulla irrilevanza urbanistica dei volumi pertinenziali interrati. Il tribunale non ha nemmeno esaminato l'accusa in relazione alle norme urbanistiche di riferimento.
2) violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per totale mancanza di motivazione in quanto il tribunale si è limitato ad affermare la non manifesta infondatezza della ipotesi accusatoria.
3) violazione dell'art. 44 d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 59 legge reg. 36/97. Osserva comunque che è erronea la tesi dell'accusa secondo cui, essendo stato rilasciato il permesso di costruire con la procedura concertativa per la variante allo strumento urbanistico, anche i successivi permessi di costruire in variante avrebbero richiesto una nuova variante urbanistica per le modifiche architettoniche, pur a parità di volumi e superfici utili. Innanzitutto, infatti, nel caso di approvazione di un progetto in variante di piano, non per questo tutto il progetto diviene piano in ogni sua parte. Altrimenti sarebbe sempre necessaria una variante urbanistica di piano per qualsiasi modifica irrilevante urbanisticamente, come per i prospetti o le componenti interne. Né si potrebbe ritenere necessaria una variante di piano per le modifiche al progetto essenziali o sostanziali, perché con ciò si introdurrebbe un elemento discriminativo assolutamente incerto. In realtà le uniche variazioni che richiedono una variante di piano sono quelle che incidono sulla parte di piano modificata perché il progetto potesse risultare adeguato ed assentibile. Del resto i piani regolatori sono connotati dalla presenza di regole generali e non da progetti architettonici. Nella specie, quindi, la variante al piano è circoscritta al solo aspetto della ristrutturazione architettonicamente non fedele senza aumenti di volume. Pertanto successivi progetti in variante recanti diverse soluzioni architettoniche e costituenti parimenti una diversa ricostruzione non fedele non necessitavano di una variante urbanistica. Tutte queste considerazioni non sono state assolutamente esaminate dal tribunale del riesame.
4) violazione dell'art. 44 d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, perché in ogni caso il vizio procedurale ipotizzato dall'accusa non sarebbe tale da inficiare addirittura la sussistenza del titolo abilitativo.
5) violazione dell'art. 44 d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell'art. 68 della legge reg. 16/2008 e dell'art. 10 delle NA del PRG. Ricorda che aveva eccepito che non sussisteva la ipotizzata illegittimità dei volumi accessori autorizzati perché non computati tra le volumetrie urbanisticamente rilevanti. Invero, per definire i volumi interrati ammissibili e la loro rilevanza urbanistica bisogna fare riferimento alle norme attuative del PRG, alle quali nella specie le contestate volumetrie accessorie e pertinenziali erano conformi. Il tribunale si è illegittimamente rifiutato di esaminare tale decisiva questione, con conseguente totale assenza di motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato perché effettivamente l'ordinanza impugnata è viziata da assoluta mancanza di motivazione oltre che da errori di diritto.
Il tribunale del riesame, invero, ha preliminarmente affermato che il suo sindacato non potrebbe investire la concreta fondatezza dell'accusa ma dovrebbe limitarsi alla verifica della astratta possibilità di ricondurre il fatto contestato alla fattispecie di reato ipotizzata dall'organo dell'accusa, sicché l'annullamento della misura cautelare sarebbe possibile solo laddove risulti ictu oculi la difformità tra fatto contestato e reato ipotizzato. In altre parole, secondo il tribunale del riesame, la sussistenza del fumus dovrebbe essere accertata solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non potrebbero essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che andrebbero valutati così come proposti dal pubblico ministero. Pertanto, sempre secondo l'ordinanza impugnata, il tribunale del riesame dovrebbe limitarsi a valutare esclusivamente che l'ipotesi dell'accusa non sia manifestamente infondata.
Si tratta di affermazioni erronee sia perché, per disporre e mantenere la misura cautelare reale, con conseguente compromissione del diritto costituzionalmente tutelato, non é sufficiente che l'ipotesi accusatoria non sia manifestamente infondata ma occorre che vi sia la prova del fumus del reato ipotizzato, sia perché il sindacato del tribunale del riesame non può limitarsi alla mera verifica della astratta possibilità di ricondurre il fatto contestato alla fattispecie di reato ipotizzata, ma deve appunto verificare la concreta sussistenza del fumus del reato.
Ed infatti, il diverso principio seguito dal tribunale del riesame, che pure a volte é stato affermato in passato da una parte della giurisprudenza di questa Corte, è stato però disatteso innumerevoli volte dalla giurisprudenza più recente, alla quale questo Collegio aderisce, secondo cui il tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia dei diritti costituzionali che la legge gli demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (cfr., ex plurimis, Sez. I, 9 dicembre 2003, n. 1885/04, Cantoni, m. 227.498; Sez. III, 16.3.2006 n. 17751; Sez. II, 23 marzo 2006, Cappello, m. 234197; Sez. III, 8.11.2006, Pulcini; Sez. III, 9 gennaio 2007, Sgadari; Sez. IV, 29.1.2007, 10979, Veronese, m. 236193; Sez. V, 15.7.2008, n. 37695, Cecchi, m. 241632; Sez. I, 11.5.2007, n. 21736, Citarella, m. 236474; Sez. IV, 21.5.2008, n. 23944, Di Fulvio, m. 240521; Sez. II, 2.10.2008, n. 2808/09, Bedino, m. 242650; Sez. III, 12.1.2010, Turco; Sez. III, 24.2.2010, Normando; Sez. III, 11.3.2010, D'Orazio).
L'erroneo criterio di giudizio seguito dal tribunale del riesame, consistente in una inusuale prognosi apodittica di non manifesta totale infondatezza della tesi dell'accusa, ha quindi inficiato la validità dell'intera decisione, la quale si è in realtà risolta in un sostanziale non consentito non liquet.
In particolare, l'indagato aveva eccepito l'infondatezza della tesi accusatoria secondo la quale, poiché il primo permesso di costruire era stato rilasciato con la proceduta concertativa per la variante allo strumento urbanistico, allora solo per questo motivo anche gli eventuali successivi permessi di costruire in variante avrebbero richiesto tutti una nuova variante urbanistica, e ciò anche se si fosse trattato di sole modifiche architettoniche a parità di volumi e superfici utili. Il tribunale del riesame si è sostanzialmente rifiutato di valutare questa eccezione limitandosi ad osservare che «non risulta del tutto manifesta la infondatezza della accusa, in quanto, effettivamente, è astrattamente sostenibile che i progetti ... apportino modifiche sostanziali al progetto iniziale tali da richiedere una nuova procedura di variante al piano regolatore generale». E ciò perché «non sembra illogico sostenere che anche le successive variazioni essenziali al progetto di ricostruzione vengano approvate seguendo la stessa procedura». E' appena il caso di rilevare che l'eccezione difensiva involveva non già una questione di fatto, bensì una questione di diritto che il tribunale del riesame aveva il compito di affrontare e risolvere anche qualora potesse condividersi la tesi restrittiva sui limiti delle valutazioni che gli spettano. Tale tesi restrittiva, invero, potrebbe al più escludere alcuni accertamenti di fatto, ma non potrebbe certo in nessun caso portare a ritenere che al giudice non spetti, in primo luogo, risolvere le questioni di diritto ed accertare la correttezza giuridica e la legittimità della ipotesi accusatoria sulla base della quale viene compressa la libertà costituzionale. Il tribunale dei riesame avrebbe quindi dovuto stabilire quale era l'esatta interpretazione delle norme che venivano in esame e non già limitarsi ad affermare, peraltro del tutto apoditticamente, che l'interpretazione del PM non era del tutto manifestamente infondata, o che era astrattamente sostenibile, o che non era illogica.
Ciò posto, rileva questa Corte che l'interpretazione acriticamente seguita (rectius: non esclusa) dal tribunale del riesame è infondata. Non può infatti ritenersi che, in caso di approvazione di un progetto in variante di piano, solo per questo tutto il progetto divenga piano in ogni sua parte. Come esattamente sostiene il ricorrente, infatti, l'atto amministrativo che approva il progetto con la detta procedura può logicamente e giuridicamente scomporsi in due diverse determinazioni con diversi effetti giuridici:
1) l'approvazione della variante al PRG, che ha effetto sotto il profilo urbanistico ed è integrativa del piano;
2) l'approvazione del progetto sotto il profilo edilizio, con il rilascio del titolo edilizio. In altre parole, a seguito della procedura, si verifica l'effetto di una variazione della disciplina di piano per l'aspetto relativamente al quale il progetto contrastava con il piano stesso e non anche l'effetto di determinare una sorta di anomala disciplina di piano regolatore integrata per il futuro da un progetto architettonico in tutte le sue componenti.
Del resto, se così non fosse, ossia se si accettasse la tesi che tutte le volte che il progetto necessita di una qualche variante al piano allora tutto il progetto si trasfonde nel piano, si verificherebbero conseguenze paradossali ed un anomalo assetto giuridico pianificatorio, giacché l'edificio approvato in origine con una qualche (anche minima) variante al PRG dovrebbe per sempre essere oggetto di variante urbanistica di piano (con la relativa procedura) per qualsiasi tipo di modifica, anche di minore rilevanza, ed anche nei casi (come quello in esame) di sola modifica dei prospetti e delle componenti interne.
Né d'altra parte appare corretta la tesi secondo cui si dovrebbe distinguere tra varianti essenziali o sostanziali e varianti non essenziali o non sostanziali rispetto al progetto. A parte il fatto che il ricorso ad un criterio di sostanzialità della variante sembrerebbe contrastare, per la sua indeterminatezza e genericità, col principio della tassatività delle fattispecie penali, va rilevato che sul piano logico la tesi esclusivamente formalistica implicitamente accettata dal tribunale del riesame comporta invece che qualsiasi progetto approvato in variante di piano diventerebbe necessariamente - solo in forza della procedura adottata - per intero componente di piano.
Al contrario, una interpretazione logica e sistematica porta a ritenere che, in tali casi, il piano è integrato solo dalla modifica indotta dal progetto, sicché le successive variazioni devono tener conto soltanto della disciplina pianificatoria che ne è scaturita, ossia del piano come modificato per quella specifica parte necessaria al fine di rendere il progetto adeguato ed assentibile, e non già prestare ossequio per sempre all'intero progetto come se fosse divenuto norma di piano.
Non può quindi essere accettata la tesi dell'accusa secondo cui tutto il progetto approvato con la procedura concertativa diventerebbe per ciò stesso parte sostanziale ed integrante del PRG.
L'interpretazione che qui si segue, d'altra parte, è conforme anche alla considerazione che il piano urbanistico generale, al pari di tutti gli atti amministrativi, è atto tipico e soggetto al principio di legalità, secondo il quale i provvedimenti amministrativi sono a numero chiuso ed hanno contenuti predeterminati dalla legge. D'altra parte, i piani regolatori sono per loro natura atti amministrativi generali a contenuto non provvedimentale ma normativo, cioè connotati dalla presenza di regole generali, e non da progetti architettonici.
Il che conferma che un progetto approvato in variante non diventa per intero regola di piano, ma comporta soltanto l'integrazione del piano con la specifica variante richiesta su di esso dal progetto. Da ciò poi deriva che successive varianti al progetto comporteranno una nuova modifica al piano e richiederanno quindi una nuova variante al piano con la procedura concertativa non già se esse abbiano carattere «sostanziale» o «essenziale» rispetto al progetto (circostanza questa irrilevante ai fini che qui interessano) bensì qualora abbiano incidenza su quella specifica parte di piano la cui integrazione si era resa necessaria per l'approvazione del progetto originario (ovvero, ovviamente, su altre norme del piano).
Nel caso di specie, prima della variante, il piano recava per la zona interessata una regola che consentiva la ristrutturazione degli edifici mediante demolizione e ricostruzione, ma solo con la modalità di un fedele recupero. La variante si era resa necessaria per permettere che l'edificio potesse essere recuperato mediante ristrutturazione non fedele mantenendo invariata la volumetria (cd. ricomposizione volumetrica). L'effetto della variante di piano era dunque quello che l'edificio in questione poteva, di li innanzi, essere ristrutturato anche non fedelmente e che ogni ipotesi architettonica proposta (a parità di volumi, superfici, destinazioni) sarebbe stata compatibile non la nuova vigente regola di piano ed avrebbe potuto essere assentita con permesso di costruire ed autorizzazione paesistica. In altre parole, avendo la variante di piano permesso la ricomposizione volumetrica non fedele, qualsiasi tipologia architettonica di ricomposizione volumetrica era divenuta compatibile con il piano.
L'integrazione del piano regolatore si era pertanto avuta soltanto in relazione al profilo della possibile demolizione e ricostruzione con ricomposizione volumetrica non fedele, senza aumenti di volume. Di conseguenza, la successiva presentazione di un progetto di variante che recava diverse soluzioni architettoniche e che costituiva parimenti una diversa ipotesi di ristrutturazione non fedele senza aumento di volumetria, non incideva sulla regola di piano così come in precedenza modificata ed integrata e non richiedeva quindi una nuova variante urbanistica, ben potendo essere assentita dal punto di vista edilizio e paesistico secondo le normali procedure.
Il tribunale del riesame non ha in alcun modo contestato la tesi della difesa, che aveva eccepito documentalmente che i nuovi progetti in variante riguardavano soltanto modifiche architettoniche e non incidevano né sulla volumetria dell'edificio né su altre regole di piano. Questo assunto di fatto deve quindi considerarsi implicitamente ammesso dalla ordinanza impugnata, in considerazione della sua assoluta mancanza di contestazione sul punto.
Ne consegue che deve escludersi la sussistenza del fumus del reato contestato sotto il profilo che i permessi di costruire in variante sarebbero illegittimi perché non approvati con la procedura concertativa.
Il reato edilizio era stato peraltro contestato anche sotto il profilo che nel volume complessivo del progetto non erano stati computati vani denominati come vani tecnici, o spazi pertinenziali o cantine. La difesa aveva eccepito che la contestazione si basava su concetti generali, senza tener conto delle norme in concreto applicabili nella fattispecie, ed in particolare di quelle di cui all'art. 10 delle NTA. Sosteneva infatti la difesa che spetta al PRG definire i volumi interrati ammissibili e la loro rilevanza urbanistica, dovendo altrimenti presumersene, alla stregua della giurisprudenza amministrativa, l'irrilevanza. La difesa aveva quindi specificamente evidenziato, anche sulla base di una perizia tecnica, che le contestate volumetrie accessorie e pertinenziali erano pienamente conformi alla norma di piano (art. 10), sia perché corrispondenti alla nozione di pertinenza, attesa la loro strumentalità e la loro specifica destinazione a cantina o ripostiglio o a vano tecnico e l'assenza dei requisiti di abitabilità, sia perché interamente collocati al di sotto della quota di riferimento.
Orbene, a fronte delle specifiche e dettagliate eccezioni della difesa, supportate anche da una perizia tecnica, l'ordinanza impugnata si è limitata ad affermare: «ritenuto che questo tribunale non possa assolutamente entrare nel merito di quanto affermato dal pubblico ministero e dal GIP in ordine alla ipotizzata creazione di volumi non consentiti». Al contrario, compito precipuo del tribunale era proprio quello di valutare il fumus della ipotesi accusatoria anche con riferimento ai volumi tecnici, tenendo adeguatamente e motivatamente conto delle considerazioni anche giuridiche svolte dalla difesa e della perizia tecnica da essa depositata. Ritiene quindi il Collegio che questo rifiuto di giudicare e questo sostanziale non liquet debbano comportare, in mancanza assoluta di qualsiasi accertamento e di qualsiasi motivazione sulla non ammissibilità dei volumi tecnici in questione alla stregua delle NTA, che gli stessi da presumere irrilevanti e quindi ammissibili.
In conclusione, la Corte ritiene che, a fronte di una siffatta ordinanza del tribunale del riesame, non possa che disporsi l'annullamento senza rinvio della stessa e del decreto di sequestro, con conseguente restituzione all'avente diritto degli immobili sequestrati.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro preventivo disposto il 4.11.2009 dal GIP di Savona ed ordina restituirsi le cose in sequestro all'avente diritto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 16 lug. 2010