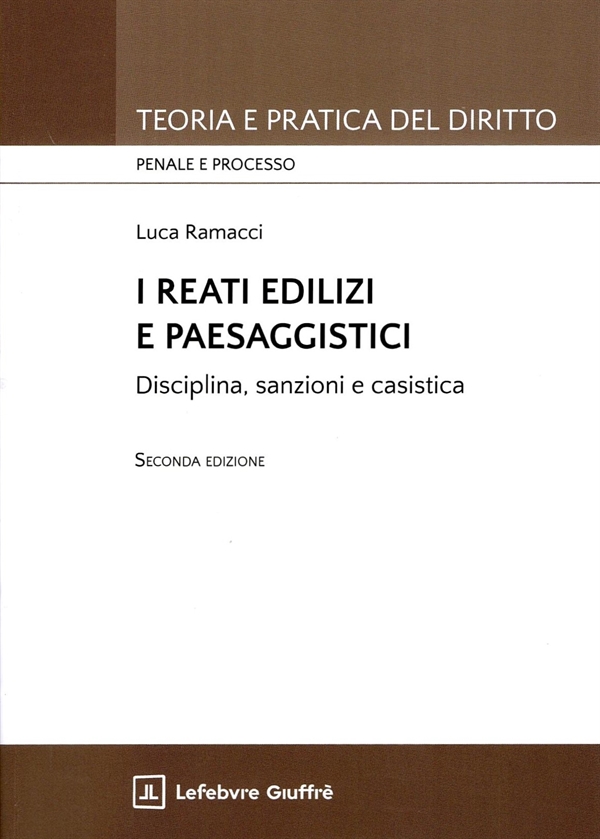Consiglio di Stato Sez. IV n. 6322 del 17 luglio 2025
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6322 del 17 luglio 2025
Urbanistica.Natura della CILA e differenze rispetto alla SCIA
La CILA ha solo una funzione informativa nei riguardi della pubblica Amministrazione circa l’avvio dei lavori (pur sulla scorta di un progetto asseverato) da parte del soggetto privato, con la conseguenza per cui le conseguenti verifiche dell’Amministrazione saranno limitate al riscontro della conformità dell’intervento al paradigma legale. In altri termini, mentre nella SCIA la sostituzione del paradigma autorizzatorio con una segnalazione privata viene compensato attraverso un controllo a posteriori che si esplica nell’esercizio, da parte dell’Amministrazione, dei poteri inibitori e di autotutela, così come espressamente declinati all’art. 19, L. n. 241/1990, nella CILA la liberalizzazione dell’attività acquista un grado di autonomia ancora più marcato. Ciò in quanto l’attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi sottoposti a SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, mentre deve essere soltanto conosciuta dall’Amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, conseguendo a ciò che ci si trova di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA). Con riferimento alla CILA, dunque, in assenza di espressi poteri inibitori o di autotutela, la P.A. potrà e dovrà solo verificare l’effettiva corrispondenza dei lavori (iniziati) a quelli consentiti tramite CILA.(segnalazione Ing. M. FEDERICI)
N. 06322/2025REG.PROV.COLL.
N. 08740/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8740 del 2023, proposto da Gennaro Ammendola, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Maria Iaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 01548/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO
1. Il signor Ammendola, odierno appellante, è comproprietario di un terreno ubicato in Napoli, in via Tito Angelini n.16, censito in NCEU, Sez. AVV, Fol.16, Part.331, Sub.38.
1.2. Con CILA del 7 aprile 2016(prot. CIL_1647_2016) il signor Ammendola comunicava al Comune “il cambio funzionale di utilizzo da abitazione ultrapopolare a locale commerciale” con opere interne di “tramezzature… finitura e rifinitura”.
1.3. Il 6 marzo 2018, l’ASL NA 1 rilasciava in favore del signor Ammendola parere favorevole in relazione all’attività di ristorazione.
1.4. In data 1 luglio 2020, il Comune adottava la comunicazione PG/300332/2016 – CIL_1647 _2016, con la quale dichiarava l’inefficacia della CILA per contrasto con le norme urbanistiche locali, sulla base delle seguenti motivazioni:
i)l’immobile “rientra … nella Zona A … disciplinata dall’art.26 delle Norme di attuazione della Variante al Prg” ed è classificato “Unità edilizia di base otto-novecentesca originaria o di ristrutturazione a blocco disciplinato dall’art.92 delle suddette NTA della variante al Prg”;
ii) non sarebbe dimostrata “la legittimità edilizia della attuale destinazione d’uso… (abitazione ultrapopolare) atteso che trattasi di locali seminterrati che per la tipologia di fabbricato e per i requisiti igienico sanitari sono destinati esclusivamente a locali deposito”;
iii) l’intervento sarebbe “in contrasto con l’art.7 delle NTA della variante al PRG che qualifica tali volumi seminterrati come volumi accessori e pertanto esclusi dal calcolo del volume”;
iv) l’intervento sarebbe “non previsto dall’art.92 delle NTA della variante al PRG che prevede le utilizzazioni di tali immobili ad esercizi commerciali sono ai piani terra e ammezzati”.
2. Con ricorso il ricorso di primo grado, presentato dinanzi al T.a.r Campania, il signor Ammendola impugnava il predetto provvedimento.
2.1. A sostegno del gravame, deduceva:
i)la nullità del provvedimento per carenza di potere;
ii)la violazione del proprio legittimo affidamento, stante la risalenza dell’intervento ad oltre quattro anni prima dell’autotutela;
iii)la violazione del contraddittorio procedimentale;
iv)l’assenza del contrasto delle opere con gli artt. 7 e 92 delle NTA.
3. Il T.a.r Campania, con la decisione 9 marzo 2023, n. 1548, ha respinto il ricorso.
4. L’originario ricorrente ha proposto appello.
5. Si è costituito nel giudizio di appello il Comune di Napoli, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
6. All’udienza 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con un primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stato dedotto che l’Amministrazione difetterebbe del potere di dichiarare l’inefficacia della CILA presentata dal signor Ammendola.
1.2. Ad avviso della parte appellante, la CILA dovrebbe essere accomunata, sul piano del regime applicabile, alla SCIA, con la conseguenza per cui l’Amministrazione dovrebbe essere tenuta ad effettuare i controlli esclusivamente nei limiti temporali previsti dall’art. 19, L. n. 241 del 1990, e dall’art. 22, d.P.R. n. 380/2001, in relazione alla SCIA, scaduti i quali, il relativo potere si consumerebbe.
Diversamente opinando, argomenta l’appellante, verrebbe irragionevolmente equiparata la posizione del privato comunicante al “silente abusivista”, perché, si assume nella prospettiva in esame, a fronte della comunicazione le conseguenze sarebbero uguali a quelle di chi nulla comunica.
2. Con un secondo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui, nel respingere il motivo con il quale in primo grado era stata dedotta la nullità della dichiarazione di inefficacia in assenza di una norma che la preveda, ha affermato che il Comune avrebbe esercitato il potere di cui all’art.27, TUE, posto che, ad avviso dell’appellante, la dichiarazione di inefficacia sarebbe espressione di un potere atipico rispetto a quello di vigilanza previsto da quest’ultima disposizione.
3. I primi due motivi di appello sono sostanzialmente connessi, implicando entrambi l’esame della questione del regime normativo applicabile alla CILA, e possono quindi essere esaminati congiuntamente.
3.1. Il Collegio ritiene che essi siano infondati.
3.2. La comunicazione di inizio lavori asseverata (c.d. CILA) è uno strumento di liberalizzazione delle attività economiche, mediante il quale si sottrae l’esercizio di queste ultime alla previa autorizzazione amministrativa.
La c.d. CILA è in particolare, un atto del privato, consistente in un elaborato progettuale dell’intervento che s’intende compiere, unitamente all’asseverazione di un tecnico abilitato, il quale deve attestare, sotto la sua responsabilità, che l’intervento stesso è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi in vigore, è compatibile con la normativa sismica e con quella sul rendimento energetico in edilizia e non tocca le parti strutturali dell’edificio
La c.d. CILA rinviene la sua attuale e vigente fonte normativa nell’art. 6- bis , d.P.R. n. 380/2001.
La disposizione prevede che “gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’Amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia [...]”.
Il comma 5, in particolare, stabilisce che “la mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quanto l’intervento è in corso di esecuzione”.
Dalla lettura della disposizione emerge come la CILA sia stata concepita dal Legislatore quale strumento residuale operante con riferimento a tutti quegli interventi non rientranti nell’attività edilizia libera (art. 6, d.P.R. n. 380/2001) ovvero non soggetti a permesso di costruire (art. 10, d.P.R. n. 380/2001) ovvero a SCIA (art. 22, d.P.R. n. 380/2001).
Detta disposizione è il frutto della novella introdotta con il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (c.d. SCIA-2), in attuazione della Legge di Riforma Madia (L. 7 agosto 2015, n. 124, di cui il menzionato decreto legislativo costituisce uno dei provvedimenti attuativi) che ha inteso razionalizzare e semplificare le procedure e i modelli di conseguimento dei titoli abilitativi, al fine di rendere più chiaro il quadro normativo di riferimento a vantaggio tanto degli operatori privati interessati quanto della pubblica Amministrazione.
Ciò in linea sia con gli indirizzi dell’Unione Europea (cfr. Direttiva Bolkestein relativamente ai servizi) finalizzati alla liberalizzazione dell’accesso alle attività, sia ai principi, parimenti di matrice euro-unitaria, di proporzionalità e ragionevolezza nell’individuazione dei procedimenti amministrativi ovvero delle forme di liberalizzazione più consone, in rapporto all’attività da svolgere, per il conseguimento delle abilitazioni richieste.
3.3. Come autorevolmente chiarito dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 1784/2016, reso sullo schema di d.lgs. n. 222/2016 che ha introdotto - come detto - l’art. 6- bis, d.P.R. n. 380/2001, la CILA condivide la medesima natura giuridica della SCIA quale istituto di liberalizzazione delle attività private.
Ed in effetti, entrambi gli istituti operano secondo lo schema “norma-fatto-effetto” poiché tanto la CILA quanto la SCIA legittimano il privato a dare avvio direttamente all’attività per il solo fatto della trasmissione all’Amministrazione della comunicazione o segnalazione e dunque costituiscono fatti idonei, per legge, a consentire l’esercizio dell’attività comunicata o segnalata.
3.4. Tanto premesso in termini generali, il Collegio non ignora l’esistenza di un orientamento interpretativo che, in linea con le argomentazioni sviluppate dalla parte appellante (ex pluribus, Consiglio di Stato, Sez. II, 24 aprile 2023 n. 411), muovendo dalla condivisa premessa secondo cui la CILA costituisce espressione della medesima logica liberalizzatrice che anima la SCIA, ne trae l’ulteriore corollario per cui alla prima sarebbe possibile applicare interamente il regime giuridico previsto per la seconda.
In particolare, per questo orientamento, occorrerebbe “mutuare in subiecta materia i principi via via consolidatisi con riferimento alla separazione tra autotutela decisoria e esecutiva in materia di s.c.i.a. o d.i.a., in particolare dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 45 del 2019. Di esse, infatti, la CILA «condivide l’intima natura giuridica», sicché trovano applicazione i limiti di tempo e di motivazione declinati nell’art. 19, commi 3, 4, 6 bis e 6 ter della l. n. 241 del 1990, in combinato disposto con il richiamo alle «condizioni» di cui all’art. 21 novies della medesima normativa”.
3.5. Tuttavia, il Collegio ritiene che tale orientamento, pur corretto nella premessa da cui trae le mosse, non possa essere condiviso nelle conclusioni alle quali giunge, in quanto non adeguatamente supportato sul piano del diritto positivo.
Ritiene, infatti, il Collegio, conformemente al citato parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 1784/2016, che non sia possibile applicare alla CILA il medesimo regime giuridico espressamente previsto in relazione alla SCIA.
Con riferimento alla CILA occorre, infatti, ad avviso del Collegio, partire dal dato incontrovertibile per cui manca nella normativa vigente qualsiasi riferimento ai poteri spettanti all’Amministrazione a seguito della comunicazione asseverata del privato.
In relazione alla CILA non si prevede, in effetti, alcuna attività di controllo che sia espressione dei poteri inibitori e di secondo grado, previsti invece nel caso della SCIA, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 19, L. n. 241 del 1990.
Più precisamente, l’art. 6- bis , prevede espressamente, in relazione alla CILA, i soli poteri sanzionatori spettanti alla P.A. per il caso in cui il privato inizi i lavori senza aver previamente presentato la CILA; non sono previsti, viceversa, poteri di controllo (siano essi repressivi, inibitori, conformativi ovvero di autotutela) come nel caso di SCIA, secondo il paradigma normativo di cui all’art., L. n. 241/1990.
Il legislatore del 2016 non richiama dunque in relazione alla CILA nessuno delle tre tipologie di controllo tipiche della segnalazione certificata (inibizione, conformazione e inibizione condizionata), ma si limita a prevedere una sanzione pecuniaria di 1000 euro per l’ipotesi di mancata comunicazione (art. 6-bis, comma 5, t.u.ed.) e a demandare alle Regioni a statuto ordinario la disciplina “delle modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco” (art. 6-bis, comma 4, t.u.ed.).
La questione ermeneutica che tale diversificato regime impone di risolvere è se l’assenza della previsione, in caso di CILA, di un potere di controllo (inibitorio) amministrativo costituisca una mera lacuna del legislatore (colmabile, magari, mediante applicazione analogica delle regole previste per la SCIA.) o sia espressione della chiara intenzione di quest’ultimo di diversificare sul punto i regimi dei due titoli abilitativi in questione (ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit).
3.6. La diversa formulazione normativa prevista per la CILA, ad avviso del Collegio, non appare il frutto di una dimenticanza del Legislatore e non consente, dunque, il ricorso all’interpretazione analogica.
La previsione di poteri solo sanzionatori corrisponde, infatti, ad una precisa ratio, consistente nel limitare l’ingerenza dei poteri pubblici in presenza di un’attività privata a limitato impatto sul territorio e, come tale, passibile di essere oggetto di sola comunicazione di inizio lavori.
La CILA, infatti, ha solo una funzione informativa nei riguardi della pubblica Amministrazione circa l’avvio dei lavori (pur sulla scorta di un progetto asseverato) da parte del soggetto privato, con la conseguenza per cui le conseguenti verifiche dell’Amministrazione saranno limitate al riscontro della conformità dell’intervento al paradigma legale.
In altri termini, mentre nella SCIA la sostituzione del paradigma autorizzatorio con una segnalazione privata viene compensato attraverso un controllo a posteriori che si esplica nell’esercizio, da parte dell’Amministrazione, dei poteri inibitori e di autotutela, così come espressamente declinati all’art. 19, L. n. 241/1990, nella CILA la liberalizzazione dell’attività acquista un grado di autonomia ancora più marcato.
Ciò in quanto l’attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi sottoposti a SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, mentre deve essere soltanto conosciuta dall’Amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, conseguendo a ciò che ci si trova di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA).(in tal senso, cfr. il cit. parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 1784/2016).
Con riferimento alla CILA, dunque, in assenza di espressi poteri inibitori o di autotutela, la P.A. potrà e dovrà solo verificare l’effettiva corrispondenza dei lavori (iniziati) a quelli consentiti tramite CILA.
In ciò, dunque, consiste la distinzione più rilevante tra gli istituti della CILA e della SCIA.
In tal senso è del resto orientata anche attenta dottrina, secondo la quale, entrambi gli istituti presentano la medesima natura giuridica e le stesse finalità, “ma si declinano in manifestazioni diversificate del potere amministrativo: nella segnalazione certificata più strutturato, nella comunicazione asseverata più attenuato, quasi etereo”.
3.7. L’orientamento condiviso dal Collegio appare maggiormente coerente con il principio di legalità, che costituisce il fondamento ed il limite dell’intera attività amministrativa, anche di quella che si esprime con l’adozione di provvedimenti di secondo grado.
In tale direzione appare orientata anche la giurisprudenza costituzionale, che, con la recente sentenza 2 luglio 2025, n. 88, superando la tradizionale prospettiva che riteneva il potere di autotutela espressione dello stesso potere esercitato in primo grado (o di un potere implicito che da questo derivava), di cui condivideva il carattere di inesauribilità, ha autorevolmente ribadito l’importanza della stretta osservanza del principio di legalità in relazione ai poteri di secondo grado, osservando, in particolare che “Il potere amministrativo, originariamente concepito come espressione di assoluta “supremazia” (salvi i limiti segnati dalla legge) e caratterizzato dalla sua “inesauribilità”, nel suo ancoraggio costituzionale è, piuttosto, una situazione soggettiva conferita al servizio degli interessi della collettività nazionale (art. 98 Cost.).
Dal descritto passaggio dalla logica della preminenza a quella del servizio deriva che la norma che attribuisce il potere per la realizzazione di uno specifico interesse pubblico fa di questo non solo il fine, ma la causa stessa del potere: proprio in quanto il potere è strumentale, va esercitato nella misura in cui serve al soddisfacimento dell’interesse pubblico ed è proporzionatamente occorrente a tal fine, quindi con il minimo sacrificio dell’interesse del privato, ma anche degli altri interessi pubblici. La sede delle relazioni tra gli interessi è il procedimento amministrativo: in questa sede, l’interesse pubblico primario, che giustifica il potere, si confronta con gli altri interessi pubblici coinvolti e con gli interessi dei privati, i quali non solo possono avere consistenza oppositiva rispetto al potere che ne invade la sfera soggettiva, ma spesse volte hanno consistenza di pretesa al suo esercizio, volto ad ampliare la sfera soggettiva, pretesa che in molti casi ha fondamento nelle previsioni costituzionali. Il corretto confronto di questi interessi, secondo la conformazione datane dalla legge, è garanzia di legittimità della decisione amministrativa, così formatasi, con la quale si esaurisce quel potere.
Il riesame del provvedimento, pur mosso da ragioni di legittimità, non costituisce espressione di quel potere già esercitato, bensì di un altro potere riconosciuto in via generale all’Amministrazione, quello dell’annullamento d’ufficio, che, proprio perché diverso da quello esercitato e su cui va a incidere, è assoggettata a regole specifiche, quanto a presupposti, a disciplina procedimentale e a portata della discrezionalità di cui la funzione di autotutela è espressione. In particolare – come si è già osservato (punto 3.2.) – in sede di riesame emerge l’esigenza di una regola di certezza e di correttezza nei rapporti tra il potere pubblico e i privati, che rende immodificabile l’assetto degli interessi che si è consolidato nel tempo.”.
3.8. A non dissimili conclusioni, come anticipato, è giunto anche il, più volte menzionato, parere del Consiglio di Stato n. 1784/2016 secondo cui “nel caso in cui la comunicazione sia utilizzata al di fuori della fattispecie legale, ossia per eseguire opere che richiedano il permesso di costruire o la SCIA o comunque in violazione della normativa in materia [...] l’Amministrazione non può che disporre degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso, come peraltro implicitamente previsto dalla stessa disposizione [art. 6- bis , d.P.R. n. 380/2001, N.d.R.] laddove fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia”.
3.9. La conclusione condivisa dal Collegio appare, infine, più coerente sul piano sistematico, perché attribuisce all’istituto della CILA una autonomia concettuale e funzionale rispetto all’istituto della SCIA dal quale, diversamente opinando, stenterebbe a differenziarsi.
3.10. La evidenziata diversità tra i regimi normativi della SCIA e della CILA non esclude, tuttavia, che debbano ritenersi operare, anche in relazione alla CILA, pur sempre i poteri di vigilanza spettanti, ai sensi degli artt. 27 ss., d.P.R. n. 380/2001, alla P.A. al ricorrere di ipotesi di abuso, e ciò sia a valle di una istanza del terzo, sia d’ufficio, con la conseguenza che anche nella CILA permangono forme di esercizio di potere repressivo da parte dell’Amministrazione, ancorché non coincidenti (e non identicamente individuate, finanche sotto il profilo lessicale) con quelle previste per la SCIA ordinaria, dall’art. 19, L. n. 241/1990.
3.11. Da quanto in precedenza osservato discende che, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 27, del d.P.R. n. 380 del 2001, l’Amministrazione comunale può certamente dichiarare l'inefficacia della CILA quando, come avvenuto nel caso in esame, essa viene utilizzata per legittimare interventi che avrebbero richiesto una SCIA o un Permesso di Costruire e, dunque, nel caso di CILA radicalmente difforme dal suo paradigma legislativo.
Di qui l’infondatezza dei primi due motivi di appello.
4. Con un terzo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistere, in relazione alla CILA presentata dall’appellante, un contrasto con le previsioni dell’art. 92, comma 9, delle NTA dello strumento urbanistico.
4.1. Ad avviso dell’appellante, la decisione impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha ravvisato la legittimità del provvedimento di inefficacia impugnato in base all’Intesa Governo-Regioni-Comuni sul Regolamento Edilizio tipo.
Ciò in quanto l’Intesa in esame non è formalmente citata nel provvedimento impugnato, ragion per cui, sotto tale profilo, la decisione impugnata integrerebbe illegittimamente la motivazione del provvedimento impugnato stesso.
5. Il motivo non è fondato.
Diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante, il riferimento da parte del giudice alla definizione contenuta regolamento edilizio-tipo, lungi dall’integrare la motivazione del provvedimento impugnato, costituisce attuazione del principio iura novit curia (o del giustinianeo dona mihi factum dabo tibi ius), che impone, come noto, che petitum e causa petendi di una domanda siano valutati dal Giudice alla luce del sistema normativo di riferimento.
Ne discende che correttamente il giudice di prime cure ha fatto riferimento al regolamento edilizio-tipo, che, al punto 21 allegato a), fornisce la definizione “seminterrato”, stabilendo che è tale “il Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.”
5.1. Alla luce del chiaro tenore testuale di quest’ultima previsione, è destituita di fondamento l’osservazione della parte appellante secondo cui l’immobile sarebbe posto al piano terra, poiché dall’esame della documentazione fotografica in atti emerge che l’accesso all’immobile dal piano campagna è in realtà l’ingresso al locale seminterrato e la corrispondenza ad altro cortile è meramente enunciata e comunque irrilevante trattandosi di diverso immobile.
Alla luce dei rilievi sopra evidenziati, anche il terzo motivo di appello deve dunque essere rigettato.
6. Con l’ultimo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non avrebbe esaminato gli ulteriori motivi del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti, ragion per cui essi vengono riproposti nel giudizio di appello.
6.1. In particolare, con il primo dei motivi riproposti la parte appellante deduce la illegittimità del provvedimento cha ha dichiarato l’inefficacia della CILA sulla base, in primo luogo, della asserita violazione dell’art. 7 della NTA.
6.2. Con il secondo motivo riproposto la parte appellante deduce la illegittimità del provvedimento cha ha dichiarato l’inefficacia della CILA sulla base dell’asserito contrasto con l’art. 92 delle NTA.
6.3. Con il quarto motivo riproposto la parte appellante deduce la illegittimità del provvedimento cha ha dichiarato l’inefficacia della CILA sulla base della mancata comunicazione dell’ignota nota SUAP 2020, cui l’appellante è estraneo ma che avrebbe dato avvio al procedimento di inefficacia, con conseguente difetto di motivazione.
6.4. Con l’ultimo motivo riproposto la parte appellante deduce la illegittimità del provvedimento cha ha dichiarato l’inefficacia della CILA sulla base della giurisprudenza che, a suo dire, escluderebbe in via generale che un immobile con un solo lato non completamente fuori terra possa definirsi seminterrato, con conseguente sua esclusione dai divieti relativi ai seminterrati, ove sussistenti.
7. Tali motivi sono inammissibili per violazione dell’art. 101, comma 2, posto che essi, diversamente da quanto sostenuto nell’atto di appello, sono stati espressamente esaminati dal giudice di primo grado (cfr. i punti dal 7.2. al 7.2.4. della decisione impugnata), e contro di essi non sono stati fatti valere specifici motivi. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm, possono essere riproposte con memoria depositata soltanto le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado.
7.1. In ogni caso, essi sono anche infondati.
Nel caso in esame, infatti, mediante CILA si è realizzata una modificazione della destinazione d'uso con variazione del carico urbanistico in contrasto con l'art. 92 delle NTA, che espressamente esclude i seminterrati del nucleo cittadino in questione dalla utilizzazione a fini commerciali.
7.2. Venendo nel caso in rilievo, per le ragioni dianzi indicate in occasione dell’esame del terzo mezzo di gravame, la fattispecie del piano seminterrato, ne discende la correttezza dell’operato del Comune, sotto il profilo della non assentibilità dell’intervento in ragione delle norme di sbarramento di cui agli artt. 7 e 92 delle NTA, che consentono la realizzazione di attività commerciali ai soli piano terra ed ammezzati (escludendo quindi i seminterrati).
7.3. Quanto all’invocato art. 14 del RE ("non costituisce cambio di destinazione d’uso il diverso utilizzo dei locali a piano terra o interrati, se precedentemente adibiti ad uso improprio”), occorre osservare che si tratta di una norma superata dalla sopravvenienza normativa costituita dalla NTA della nuova variante, il cui art. 4 (Efficacia e validità) stabilisce: “1. Le disposizioni del presente strumento di pianificazione urbanistica sostituiscono integralmente, per le aree in esso ricadenti, quelle del Piano regolatore generale del comune di Napoli approvato con D.m. n.1829, del 31 marzo 1972, e successive modificazioni. In caso di contrasto tra le prescrizioni del presente strumento urbanistico e altre discipline comunali, anche regolamentari, prevale la normazione da quest’ultimo prevista, se di competenza dello strumento urbanistico…”.
8. Con il terzo motivo riproposto la parte appellante deduce la illegittimità del provvedimento cha ha dichiarato l’inefficacia della CILA non adeguatamente valutando i requisiti-igienico sanitari del locale, positivamente valutati dal parere favorevole ASL 2018.
9. Il motivo è palesemente infondato posto che l’evidenziato contrasto urbanistico non può essere escluso in virtù dell’avvenuto rilascio del parere dell’ASL per l’attività di ristorazione, venendo in tale ultimo caso in rilievo l’esercizio di un potere finalizzato a curare un interesse pubblico specifico del tutto diverso rispetto a quello individuato dalle NTA violate.
10. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
11. La particolarità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere