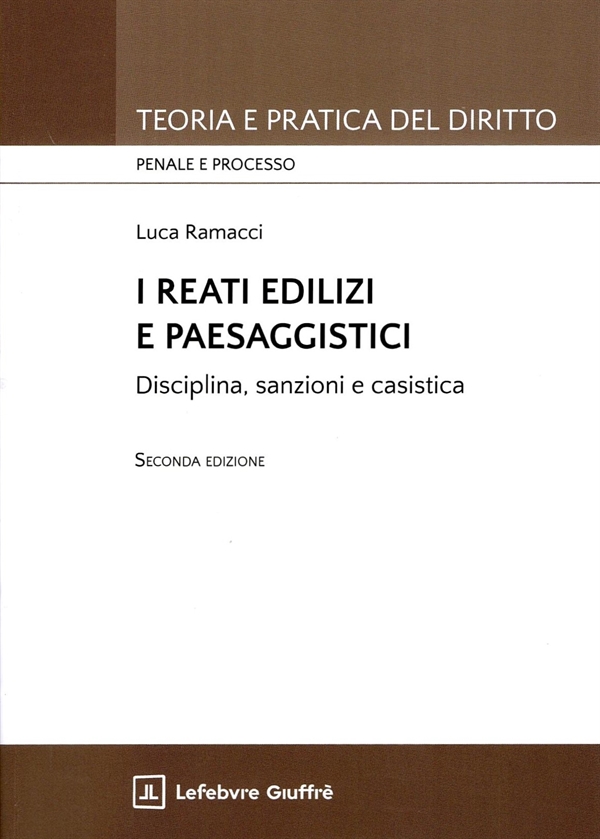Come
insegna la bibliografia corrente, l'alterazione delle
prove diagnostiche può essere ottenuta sia con sostanze prive di effetti
farmacologici (essenza di trementina, petrolio), sia con prodotti
farmaceutici regolarmente in commercio e
normalmente impiegati come antinfiammatori, l'inoculazione
dei quali deve avvenire esclusivamente in sede intramuscolare
profonda, e non già
per via intradermica.
In
entrambi i casi (di inoculazione di sostanza estranea priva di effetti
farmacologici, ovvero di inoculazione impropria di farmaci) si
determinano nell'animale reazioni dolorose ed altre reazioni
locali che vanno dall'edema fino alla necrosi senza
considerare possibili sofferenze a carico di particolari organi quali
fegato e rene.
Gli
ulteriori accertamenti sanitari necessari a risolvere casi di sospetta
reazione aspecifica alla prova diagnostica sono fonte, poi, di
sofferenza, relativa al semplice contenimento dell’animale, agli esiti
di inoculazioni o di prelievi
ematici.
Infine,
la conseguenza inevitabile della
fraudolenta somministrazione è sempre l'anticipata uccisione
dell'animale: ciò sia nel
caso in cui la frode sfugga al
primo controllo sanitario, effettuato nel corso della visita in stalla,
atteso che la macellazione coatta
consegue necessariamente all'accertata
"positività” alla malattia, sia nel caso in cui, emergendo sospetti
della frode, si renda necessaria
l'esecuzione di esami più approfonditi tra cui quello autoptico,
al fine di acquisire prove attendibili circa l'esistenza o meno
della malattia.
Alcuni
degli imputati del processo in esame, per
neutralizzarare le prove diagnostiche, si erano avvalsi di farmaci
reperiti sul mercato (BucK 19); in altri casi è dubbia la
natura della sostanza inoculata, così come
del tutto sconosciute le modalità di somministrazione.
In
ogni caso, un approfondimento di tali circostanze
incidenti, come visto, sull'aspetto sofferenza
animale avrebbe potuto avvenire soltanto attraverso la
regressione del processo alla sua fase iniziale, per
una eventuale estensione dell'azione
penale anche al reato di maltrattamento di animali
previsto dall'art.727 c.p., essendo comunque
certa, in tutti i
casi considerati, sia la
sofferenza dell'animale, nella
sua duplice forma
sopra considerata, sia la ingiustificata
uccisione di esso, quale conseguenza della
condotta di fraudolenta somministrazione.
Tale
regressione, astrattamente possibile, è
stata nella specie
inibita dalla intervenuta prescrizione del reato.
Trattasi,
infatti, di illecito contravvenzionale punito con la sola ammenda,
per il quale l'art.157 c.1 n.6 c.p. prevede il termine di
prescrizione di due anni.
Lo
scopo di questa breve nota è pertanto
quello di stimolare, per i casi analoghi a quello sopra descritto, la
riflessione e l'impegno degli operatori coinvolti
nella prevenzione e repressione dei comportamenti umani
inutilmente produttivi di sofferenza psicofisica, se
non anche lesivi della dignità
dell'animale.
Fra
le varie condotte di reato previste dall'art.727 c.p. quella degli
allevatori del caso in esame potrebbe configurarsi come "incrudelimento
verso animali senza necessità'".
In astratto
sarebbe ipotizzabile una rilevanza della sola sequenza
antecedente alla morte, costituita
dalla somministrazione della sostanza idonea per sua natura
o per le modalità della somministrazione stessa
a cagionare dolore.
Il
reato andrebbe escluso qualora si dovesse ritenere che, pur sussistendo
nella specie l'elemento della non necessità
dell'incrudelimento (il che è evidente, visto che la condotta è stata motivata
esclusivamente da intenti speculativi), la semplice sofferenza
derivante dalla somministrazione come
sopra praticata sul corpo dell'animale, e dagli accertamenti sanitari
successivi, non sia oggettivamente di entità
tale da potere rientrare nel concetto di maltrattamento.
E’
altresì ipotizzabile una rilevanza dell'intera sequenza,
ossia della sofferenza (diretta e indiretta) seguita
dalla inevitabile uccisione dell'animale.
Potrebbe,
infine, ipotizzarsi una rilevanza dell'evento
morte, a prescindere dal fatto che essa sia o
meno preceduta da sofferenza.
La
configurazione del reato per ciò che attiene la
prima ipotesi non dovrebbe presentare problemi, attesa l'evoluzione
giurisprudenziale in materia: infatti, se da una parte la giurisprudenza
prevalente ritiene che l'elemento della sofferenza
sia insito in tutte le ipotesi di maltrattamento previste
dall'art.723 c.p. (quindi non solo in quelle dell'incrudelimento
senza necessità e delle sevizie, ma anche
in quelle di detenzione di animali in condizioni
incompatibili con la loro natura: così
Cass. pen. sez.3 del
29.01.97 ud.01.10.96; Cass.pen. sez.3 del 16.03.98
ud.06.02.98), dall'altra si riconosce che tale
sofferenza non presupponga necessariamente una lesione
dell'integrità fisica dell'animale, ma possa consistere anche nello stato di
abbandono derivante da omissione di cure (così
Cass.pen.sez.5 del 28.08.98 –ud.13.08.98 che ha ravvisato il
reato di cui all'art.727 c.p. nell'ipotesi di mantenimento di un
cane in condizioni di denutrizione e di infestazione
da zecche e pulci), ovvero anche da puri e semplici
patimenti (così Cass.pen.sez.3 del 29.01.99
ud.21.12.98 con
riferimento al mantenimento di un cane con catena corta e
senza riparo dal sole).
Tale
interpretazione appare conforme alla "ratio” del nuovo
art.727 c.p., così come modificato con legge 22 novembre 1993 n.473: con
essa la repressione penale del maltrattamento che prima della
modifica legislativa era considerato unicamente come un
reato offensivo del sentimento di umana pietà verso gli animali
realizza una forma di tutela diretta dell'animale inteso come essere vivente
(così Cass.Pen. sez.3, sent.12910 del 11.12.98 - ud.13.10.98).
Da
tale affermazione giurisprudenziale potrebbe trarsi
la conclusione che il reato può sussistere anche se la condotta
umana, oggettivamente idonea
a determinare ingiustificati patimenti nell'animale,
non urti anche con i sentimenti dell'uomo:
cosa che è forse da ritenere nel
caso in esame, ove la condotta
di fraudolenta somministrazione rientra in una prassi
molto diffusa fra gli allevatori, generalmente tollerata dall'indifferente
collettività dei
consociati, che spesso guarda al bovino quale potenziale
“alimento” e che si allerta prevalentemente, solo laddove sia
ravvisabile un attentato alla salute propria (pericolo
nella specie inesistente ed
inesistente, quindi, l'offesa alla "pietas” umana
visto che i bovini macellati non sono stati commercializzati e non si
è realizzata alcuna violazione di norme poste
a tutela dell'igiene degli alimenti (art.5 L.n°283/62).
Si coglie
l'occasione per rilevare che il mutamento
di oggettività giuridica del reato (la cui repressione,
come detto, dovrebbe garantire la tutela dell'animale
in quanto essere vivente e non necessariamente anche
la sfuggente e mutevole sensibilità umana) giustificherebbe
un mutamento anche del "nomen juris” della condotta
("incrudelimento") che lo ponga in linea col titolo della
rubrica ("maltrattamento"): ciò che oggi rileva non è
la connotazione soggettiva della condotta più o
meno crudele quanto la sua oggettiva idoneità a
produrre sofferenza, semprecchè,
ovviamente, tale sofferenza non sia giustificata dalla
"necessità” (nel caso contrario, non ha comunque alcun
senso parlare di "crudeltà” non necessaria, dato che
quest'ultima è, per definizione, gratuita).
L'evoluzione ulteriore
della cultura giuridica potrebbe
d'altronde giovarsi di un'utile riflessione sul fatto che
la condotta di "maltrattamento”, allorchè abbia come
soggetto passivo l'essere umano (art.572 c.p.), si caratterizza
come tale per la sua oggettiva idoneità
a produrre patimento psicofisico nella
vittima, anche a prescindere dalla
"crudeltà” del suo autore, elemento che semmai rileva sotto il diverso
profilo della intensità del dolo.
D'altronde,
facendosi interprete della mutata sensibilità
giuridica e
anticipando la modifica legislativa introdotta dalla legge n°473/93,
la giurisprudenza sosteneva che
sono punibili ex art.727 c.p. non soltanto quei comportamenti
che offendono il comune sentimento di pietà
e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola
"incrudelire” o che destino ripugnanza -), "ma anche
quelle condotte
ingiustificate che incidono
sulla sensibilità dell'animale
producendo un dolore, pur
se tali condotte non siano accompagnate dalla
volontà di infierire
sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di
abbandono o incuria”....
“in via di principio, il reato di cui all'art.727
c.p., in considerazione
del tenore letterale
della norma (maltrattamenti) e del contenuto di essa (ove si
parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenze e affaticamento),
tutela gli animali in quanto autonomi
esseri viventi, dotati di sensibilità
psicofisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove
essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela
penale è, dunque, rivolta agli animali
in considerazione della loro natura. Le
utilità morali
e materiali che essi procurano all'uomo devono essere assicurate
nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche
e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità,
è portatore." (così
Cass. Pen. sez.3 sent.06122 del 27.04.90 ud.14.03.90).
In
applicazione di tali principi, non dovrebbero
esservi difficoltà nel riconoscere la sussistenza del
reato di maltrattamento anche nella semplice
somministrazione di sostanze idonee a procurare dolore, senza alcuna
necessità.
Nel
caso in esame, alla condotta di somministrazione
produttiva, come detto, di conseguenze dolorose per gli animali
è conseguita poi l'anticipata
uccisione degli stessi.
In
tale ipotesi, dovrebbe applicarsi il disposto
di cui all'art. 727 c.p., che prevede un aggravamento di pena
"se il fatto… causa la morte dell'animale”.
Nella
specie, la morte, anche se
non costituente conseguenza naturalistica della condotta di
somministrazione o degli
accertamenti sanitari successivi, è
nondimeno addebitabile all'allevatore, quale conseguenza da lui
voluta proprio al fine di poter lucrare
l'indennizzo corrisposto dalla Regione per i casi di accertata positività
alla malattia (brucellosi o
tubercolosi).
La
condotta di maltrattamento dovrebbe pertanto
ritenersi aggravata ai sensi del secondo comma dell'art.727 c.p. .
Qualora,
infine, si dovesse ritenere che la condotta
di somministrazione in esame non sia produttiva di
sofferenze oggettivamente apprezzabili, e
pertanto giuridicamente rilevanti come maltrattamenti,
resterebbe da stabilire quale rilevanza penale
assegnare all'ingiustificata uccisione
dell'animale: con la precisazione che, trattandosi di animale di
proprietà dello stesso
responsabile dell'evento, il fatto non potrebbe ricadere sotto
la sanzione di cui all'art.638 c.p.: tale norma punisce infatti
soltanto la ingiustificata uccisione di animali "che
appartengano ad altri", ed è quindi
ben lungi dal tutelare l'animale in quanto essere vivente,
bensì solo il patrimonio
del suo proprietario, alla cui tutela fa riferimento il
titolo XIII del codice, nel cui capo I è classificato
il reato di cui all'art.638 del codice penale.
Anche
valutato nell'ottica della vecchia normativa, che
prevedeva, come detto, solo una tutela dei sentimenti umani, e non già
dell'animale quale essere vivente, nessun
atto di incrudelimento avrebbe dovuto turbare di più
la sensibilità umana della uccisione
di un animale (non rileva se da parte di un terzo o
dello stesso proprietario dell'animale), non giustificata da alcuna
necessità: con riferimento
all'ipotesi dell'uccisione immotivata di un
cane randagio a colpi di fucile, la S.C. affermava la
sussistenza del reato, perché atti
di crudeltà di questo
tipo avrebbero potuto divenire, ove tollerati, una
"scuola di morale insensibilità alle altrui sofferenze"
(Cass.Pen. sez.3 del 25.11.82 ud.24.09.82).
Il
mutamento di valori di cui è espressione la
modifica legislativa dell'art.727
c.p. non giustifica più la liceità
della uccisione dell'animale proprio,
e fa apparire quindi irragionevole la limitazione della
repressione penale al solo reato di maltrattamenti, con esclusione di
quello, più grave, di
uccisione ingiustificata.
(considerazioni, queste, ampiamente svolte dal Pretore
di GROSSETO nell’ordinanza 04.10.94
di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la ritenuta
illegittimità dell'art.727 c.p. in
relazione agli artt.3 e 10 Cost.)
La
regolamentazione della uccisione di animali selvatici è
affidata a leggi speciali, e non è
questa la sede per valutare i limiti e
la qualità della
"tutela” di cui essi siano, in
ipotesi, destinatari.
Quanto
detto finora vale invece per tutti gli animali "propri", da affezione
o meno che siano: per
i primi, infatti, la normativa speciale di cui alla
legge quadro 14.08.91 n°281 nulla innova rispetto all'art.727
c.p., poiché, pur
prevedendo all'art.2 il divieto di una loro uccisione
ingiustificata, lo limita ai soli cani e gatti, (mentre la legge ha
portata più ampia, essendo diretta a tutelare
tutti gli animali da affezione: il divieto di
abbandono di cui all'art.5 c.1 riguarda infatti
"cani, gatti o qualsiasi animale custodito nella propria
abitazione"); e, in ogni caso non prevede alcuna sanzione per
la violazione di tale divieto.
Le
uniche sanzioni previste all'art.5 Legge 281/91 concernono
infatti condotte diverse e meno gravi della uccisione ingiustificata ed
hanno comunque natura amministrativa.
L'animale,
da allevamento o da affezione che sia, può
pertanto essere ucciso senza necessità, e tale comportamento è lecito
penalmente (oltre che amministrativamente).
Il
vuoto legislativo non può
essere colmato in via interpretativa,
anche se, prendendo la mossa dalle ultime
evoluzioni della giurisprudenza (che, come visto, considerano
maltrattamenti anche la semplice inflizione di "patimenti", pur se
non accompagnata da una vera e
propria lesione all'integrità
fisica dell'animale) si potrebbe essere indotti a notare che,
quantomeno in casi analoghi a quelli in esame, non esista morte non
preceduta da "patimento”, ravvisandosi
questo quantomeno nell'inevitabile e certo
innaturale costrizione fisica e nei mezzi anche minimamente
dolorosi che precedono la macellazione: il tutto sarebbe penalmente lecito,
ove, appunto la macellazione fosse
giustificata dalla
"necessità” alimentare
con l'esecuzione di manovre corrette, nel rispetto non
solo della normativa del settore, ma soprattutto
delle buone tecniche di allevamento che impediscano la macellazione di
un animale immaturo. Esclusivamente in queste condizioni
si sottoporrà l'animale al minimo
patimento possibile. La macellazione ingiustificata, per
contro, rientra tra le condotte
punite dall'art.727 del codice penale.
Tanto
dicasi sul piano della mera provocazione intellettuale,
(peraltro giustificata dalla irragionevolezza del silenzio
legislativo sul punto), e non certo quale
proposta di interpretazione "estensiva”
dell'espressione "maltrattamento” anche alla condotta di uccisione
ingiustificata: infatti una siffatta interpretazione è
preclusa dal principio di legalità (art.2 c.p.).
Proprio
in considerazione di tale principio,
la Corte Costituzionale, con
sentenza n°411 del 1995, ha dichiarato inammissibile
la questione di legittimità
costituzionale dell'art.727 del codice penale, sollevata, in riferimento
agli artt.3 e 10 della Costituzione, dal Pretore di GROSSETO
con l'ordinanza sopra citata.
La
Corte ha osservato che "una pronuncia additiva, dalla quale consegua
l'inserimento nell'impugnato art.727 c.p. di una norma incriminatrice
della condotta posta in essere da colui che provoca la
morte di un animale di sua proprietà, non rientra
fra i poteri costituzionalmente spettanti a questa
Corte. Infatti al giudice costituzionale non è
dato di pronunciare una decisione dalla
quale possa derivare la creazione
esclusivamente riservata al legislatore
di una nuova fattispecie penale: e ciò
in forza del principio di legalità
sancito dall'art.25, secondo comma,
della Costituzione".
Spetterà
pertanto all'iniziativa degli enti ed associazioni
protezioniste, degli operatori sanitari, oltre che dei singoli, sollecitare
l'intervento del legislatore per una modifica della norma che la renda
conforme alla "ratio” della tutela penale, destinata all'animale
quale essere vivente degno del rispetto dell'uomo.
Dott.Claudio
Biglia
Veterinario
Dirigente ASL3 TORINO
Dott.ssa
Marisa Vassallo
Magistrato
presso la Corte d'Appello di TORINO