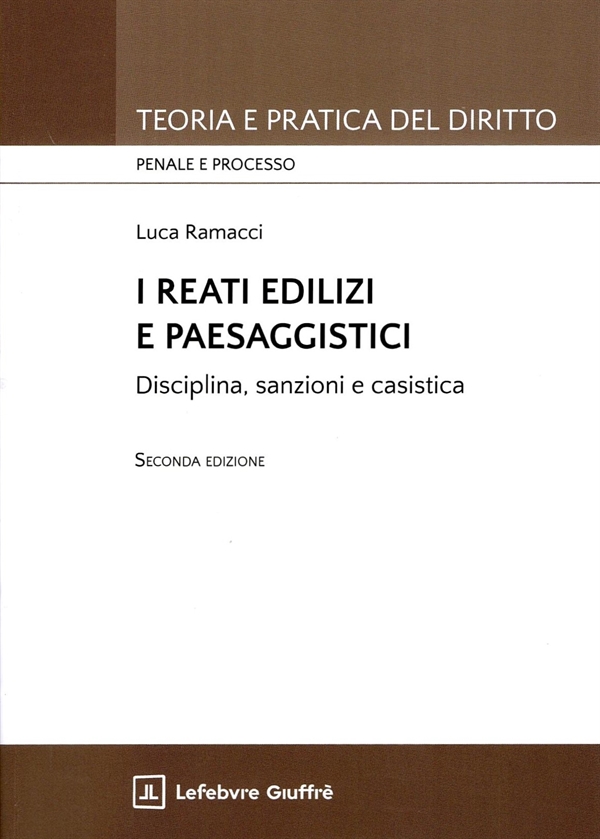Presidente: Grossi M. Estensore: Perconte Licatese R. P.M. Cafiero D. (Conf.)
Comune Canosa (Lamesta) contro Calò (Palmieri)
(Rigetta, App. Bari, 17 maggio 1995).
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - Danno ambientale - Dolo o colpa - Necessità - Prova - Onere del danneggiato.
L'ente territoriale, che agisce per il risarcimento del danno ambientale, deve dimostrare il dolo o la colpa del danneggiante, e, quindi, dopo la legge 8 luglio 1986 n. 349, la violazione di "disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge", altrimenti vigendo il principio "qui iure suo utitur neminem laedit".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE CANOSA DI PUGLIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 230, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO FARACI, difeso dall'avvocato PIERO LAMESTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CALÒ GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MADDALENA RAINERI 12, presso lo studio dell'avvocato SABINO FACCIOLONGO, difeso dall'avvocato ANGELO PALMIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 461/95 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 12/04/95 e depositata il 17/05/95 (R.G. 284/88);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/97 dal Relatore Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Dott. Angelo PALMIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Canosa di Puglia convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, Calò Giacomo, titolare della omonima ditta operante nel settore dell'estrazione e dello sfruttamento dell'argilla, per sentirlo condannare al pagamento di lire 500 milioni, o altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni, per avere deturpato irrimediabilmente, proseguendo nelle attività estrattive senza concessione e anche in spregio di un'ordinanza sindacale che gli aveva ingiunto la sospensione dei lavori, una delle sette colline circostanti all'abitato. Il Calò, proseguiva l'attore, era stato condannato dal pretore, con sentenza del 3 luglio 1981, per la contravvenzione di cui agli artt. 1 e 17 lett. B della legge 28 gennaio 1977 n. 10. Il convenuto opponeva la piena legittimità del suo operato, autorizzato dal Corpo delle Miniere e peraltro sempre conforme alle norme della legge e della tecnica.
Nel corso dell'istruzione, il Calò, con sentenza del 5 dicembre 1983, veniva assolto dall'imputazione di cui sopra perché il fatto non sussiste, e tale pronuncia passava in cosa giudicata. L'adito Tribunale, con sentenza del 31 dicembre 1987, rigettava la domanda.
La Corte di Appello di Bari, con la sentenza ora impugnata, emessa il 17 maggio 1995, ha respinto il gravame principale del Comune e quello incidentale del Calò, che si era doluto della compensazione delle spese del primo grado.
La Corte territoriale ha anzitutto escluso, in forza del giudicato, che lo sfruttamento della cava fosse soggetto a concessione, sia pure a norma del locale regolamento edilizio.
Comunque, ha argomentato, sta di fatto che il Comune non ha dedotto l'esistenza di un danno ambientale tutelabile civilmente e risarcibile, ma solo la violazione dell'interesse generale al mantenimento del patrimonio ambientale, inidoneo a costituire un diritto soggettivo azionabile, onde l'evidente superfluità dell'ispezione e della consulenza tecnica chieste in prime cure e non ammesse dal Tribunale. Ha poi rilevato che il Comune, con l'appello, ha dedotto, oltre alla lesione di interessi diffusi, anche un generico danno a cose, di cui neppure assume la proprietà o disponibilità, lese non nel particolare pregio loro conferito dall'ambiente ma nella loro materialità e consistenza, danno questo sicuramente esulante dai confini di quello ambientale e che si inserisce invece in quello residuale per così dire "ordinario", con un'immutazione della "causa petendi" così radicale da comportare la novità della domanda, pertanto inammissibile in appello (art. 345 c.p.c.), e da non giustificare alcuna indagine istruttoria. Ricorre per la cassazione di tale sentenza il Comune, sulla base di tre motivi, cui risponde l'intimato con controricorso, illustrato da una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 652 c.p.p. e dell'art. 2 lett. B della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente afferma che la sentenza assolutoria del giudice penale rende solo incontestabile che il Calò, avendo gestito la cava senza la concessione edilizia, non ha commesso la contravvenzione di cui agli artt. 1 e 17 lett. B della legge 28 gennaio 1977 n. 10, ma non impedisce che nella sua condotta possano ravvisarsi altre violazioni, di norme amministrative, come l'art. 6 del Reg. edilizio comunale (che esige, per l'apertura o l'ampliamento di nuove cave, la licenza di costruzione), non disapplicabile "incidenter tantum", per difetto di giurisdizione, dal giudice ordinario, o civilistiche, come l'art. 2043 c.c.. Viceversa la Corte d'appello ha ritenuto di estendere il giudicato anche ai fatti materiali estranei alla contestazione penale e in nessun modo accertati nel giudizio penale. Tali censure, per la loro infondatezza, non sono meritevoli di accoglimento.
La sentenza penale, passata in giudicato, di assoluzione del Calò ha solo stabilito che, per l'apertura e l'esercizio della cava d'argilla, in assenza di opere urbanistiche, l'imputato non aveva l'obbligo di munirsi della concessione edilizia, onde l'insussistenza della contravvenzione ascrittagli (artt. 1 e 17 lett. B della legge 28 gennaio 1977 n. 10); escludendo nello stesso tempo, almeno per implicito, che un obbligo siffatto potesse scaturire, piuttosto che dalla legge, da una fonte normativa secondaria e subordinata alla legge, come l'art. 6 del regolamento edilizio comunale.
La Corte di merito, preso atto di ciò, si è limitata ad osservare correttamente che, per effetto del giudicato penale assolutorio, non può adesso ritenersi il contrario, che cioè l'attività del convenuto appellato "fosse soggetta a concessione", ma non ha affatto rifiutato aprioristicamente la possibilità che nella condotta del Calò potessero ravvisarsi violazioni di norme diverse, di qualsiasi natura, perché nessuna affermazione in tal senso si rinviene nella motivazione, la cui lettura smentisce dunque nettamente l'assunto che la Corte territoriale avrebbe esteso l'efficacia del giudicato penale "anche ai fatti materiali non oggetto di accertamento nel giudizio penale".
Quanto alla disapplicazione dell'art. 6 del regolamento edilizio, la Corte d'appello non si è posta "ex professo" il problema, sia per averlo ritenuto già risolto dal giudice penale ("per quanto giustamente argomentato dal giudice d'appello penale") sia perché giudicato comunque superfluo ai fini della decisione. Occorre tuttavia chiarire che, qualora, a torto o a ragione, avesse reputato di dover ribadire tale disapplicazione, avrebbe legittimamente esercitato il potere riconosciuto al giudice ordinario dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E, a tenore del quale "le autorità giudiziarie applicheranno (...) i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi"; non essendo dubitabile che spetti soltanto alla legge prescrivere, nei singoli casi, la necessità della concessione edilizia (art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10).
Col secondo motivo, denunciando la falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), il Comune ricorda che, col proprio atto introduttivo del giudizio, allegò l'esistenza del danno ambientale facendo specifico riferimento non alla violazione degli artt. 1 e 17 lett. B della legge n. 10 del 1977, "ma, in maniera generica, sia al danno ambientale che al danno generico", mettendo in luce non solo lo "scempio" dei "doni naturali" ma altresì un comportamento del Calò "fortemente lesivo degli interessi della collettività in generale e del Comune di Canosa di Puglia in particolare". Nella comparsa conclusionale spiegò poi "in cosa era consistito il comportamento fortemente lesivo". Il Tribunale, esaminando questi ultimi profili di una possibile responsabilità, concernenti la violazione, da parte del Calò, di varie prescrizioni (normative, tecniche o di comune prudenza), li ritenne, è vero, infondati; ma tanto basta ad escludere la ritenuta "novità" della domanda in secondo grado, non configurandosi una domanda nuova "se su di essa già vi è motivata decisione in primo grado". Il capo censurato resiste alle critiche, per vero poco pertinenti, del ricorrente.
Rileva la sentenza impugnata, "in parte qua", come in appello il Comune abbia dedotto "anche, oltre alla lesione di interessi diffusi, danni reali, quali quelli derivanti dalla rottura delle strade, dalla insalubrità delle acque stagnanti". In tal modo, prosegue il giudice di merito, il Comune "allega un generico danno a cose (di cui neppure assume la proprietà o disponibilità) lese non nel particolare pregio loro conferito dall'ambiente (...) ma nella loro materialità e consistenza (...); e cioè "un danno che sicuramente esula dai confini di quello ambientale per inserirsi in quello residuale per così dire ordinario, con evidente immutazione della "causa petendi" dell'azione così radicale da comportare la novità della domanda", pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Orbene, come è un dato ormai acquisito in dottrina e in giurisprudenza, deve distinguersi, con riferimento ad un'azione di risarcimento del danno ambientale promossa da un Comune, tra il danno ai singoli beni, di proprietà privata o pubblica, o comunque a posizioni soggettive individuali, che trovano la loro tutela nelle regole ordinarie; e il danno all'ambiente considerato in senso unitario, quale bene a sè stante, ontologicamente diverso dai singoli beni che ne formano il substrato, in cui il profilo sanzionatorio, nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale, comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale, bensì della compromissione dell'ambiente, vale a dire della lesione, in sè del bene ambientale (cfr. Cass. 1 settembre 1995 n. 9211). L'ambiente in senso giuridico, quale bene unitario ma anche immateriale (Corte cost., sent. 30 dicembre 1987 n. 641), rappresenta cioè un insieme che, pur comprendendo vari beni o valori, si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una realtà, priva di consistenza materiale, ma espressione di un autonomo valore collettivo, specifico oggetto, come tale, di tutela da parte dell'ordinamento, rispetto ad illeciti, la cui idoneità lesiva va valutata con riguardo a siffatto valore e
indipendentemente dalla particolare incidenza verificatasi su una o più delle dette singole componenti, secondo un concetto di pregiudizio che, sebbene riconducibile a quello di danno patrimoniale, si connota tuttavia per una più ampia accezione di danno "svincolata da una concezione aritmetico- contabile" (Cass. 9 aprile 1992 n. 4362; cfr. altresì Corte cost., sent. cit.). Lo stesso fatto può comportare, oltre che un danno all'ambiente, da risarcire in considerazione del suo valore di assieme, che ovviamente prescinde dal valore patrimoniale delle singole componenti, anche un danno a una o più di queste ultime, risarcibile invece in termini di stretta equivalenza pecuniaria. Emerge così, per diversità di oggetto e di criteri di
quantificazione del danno (prescindendo, per adesso, dai profili concernenti la legittimazione attiva e le condotte lesive), la profonda differenza strutturale tra il danno all'ambiente, sempre di natura pubblicistica, e il danno da lesione di determinati beni, privati o pubblici, ancorché entrambi ricadano nell'ambito della tutela aquiliana apprestata dall'art. 2043 c.c..
La doverosa indagine di fatto, autorizzata dal denunciato "error in procedendo", permette di verificare che le deduzioni ulteriori e peculiari contenute, rispetto alla citazione (dove era esclusivo riferimento alla menomazione paesaggistica subita dal territorio comunale, derivata dalla distruzione della collina), nella comparsa conclusionale di primo grado (come lo sfaldamento e il dissesto delle strade o le piantagioni compromesse dalle polveri diffuse nell'aria), e di qui trasferite nell'atto di appello (in cui si accenna, oltre che alla lesione di "interessi diffusi", anche ai "danni reali" già prima evidenziati), in quanto espressione di un'ordinaria pretesa risarcitoria residuale per il danneggiamento di beni determinati, inclusi o meno nel più generale quadro ambientale e paesaggistico, provocarono un radicale mutamento dell'originario "thema decidendum", introducendo nel processo una nuova "causa petendi", fondata su situazioni e premesse giuridiche e di fatto prima non prospettate, con la conseguente introduzione di una domanda nuova, giustamente sanzionata dalla Corte territoriale con la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. Il ricorrente mostra di non avere ben inteso il senso e i limiti della novità rilevata dalla Corte d'appello, la quale non ha nulla a che vedere col diverso tema concernente le molteplici violazioni che avrebbero contraddistinto "il comportamento fortemente lesivo" del Calò ( ritenute non provate dal Tribunale), di cui si dirà più oltre.
Col terzo motivo infine, prospettando il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi degli artt. 134 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att., nonché la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente, premesso che l'ordinamento riconosce, come diritto della personalità, la pretesa alla conservazione dell'ambiente (bene giuridico distinto dai beni privati e pubblici, che lo compongono), e che il danno patrimoniale sofferto per la lesione del bene dell'ambiente riguarda tutti i soggetti che ne risentono gli effetti; osserva che al Comune, rappresentante della collettività danneggiata, non può disconoscersi la legittimazione a far valere tale diritto, quale interesse collettivo azionabile in sede civile, anche prima della legislazione speciale in materia. I giudici di merito, conclude il ricorrente, contraddittoriamente, da un lato hanno rigettato l'istanza di ispezione e di consulenza tecnica intese ad accertare il danno, e dall'altro hanno respinto la domanda per la mancata prova del danno medesimo.
Queste doglianze, pur racchiudendo una parte di verità,, non possono indurre alla cassazione della sentenza.
La Corte d'appello, nel solco di Cass. 9 marzo 1979 n. 1463, afferma che il Comune "non ha dedotto l'esistenza di un danno ambientale tutelabile civilmente e risarcibile (che (...) non è dipendente dalla generica lesione del bene costituito dall'ambiente, ma è collegato alla disponibilità esclusiva di un bene, la cui conservazione, nella sua attuale potenzialità di recare utilità al soggetto, sia inscindibile dalla conservazione delle condizioni ambientali), ma solo una violazione dell'interesse generale al mantenimento del patrimonio ambientale, non tutelabile civilmente per la sua inidoneità a costituire diritto soggettivo azionabile". Così argomentando la Corte d'appello adotta una concezione, più che riduttiva, addirittura negativa del danno ambientale come categoria giuridica autonoma, prescindendo dalle più recenti acquisizioni in materia e dal complesso di principi elaborati in questi ultimi anni, specie dopo la fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 641 del 30 dicembre 1987, e ignorando per giunta del tutto gli spunti interpretativi ricavabili, anche per il passato, dalla legge 8 luglio 1986 n. 349. L'art. 18 di tale legge, lungi dall'innovare in tutto e per tutto la materia, ha in gran parte sanzionato e riconosciuto una realtà giuridica da tempo incontroversa, come per es. la legittimazione attiva degli enti territoriali all'azione risarcitoria per la lesione dell'ambiente (legitti-mazione che peraltro la stessa Corte territoriale non mette in discussione), nel quadro di una protezione preordinata alla salvaguardia di un "elemento determinativo della qualità della vita" e che "non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un "habitat" naturale nel quale l'uomo vive ed agisce (...), necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti", di cui sono interpreti gli artt. 9 e 32 Cost. La funzione solo ricognitiva, in gran parte, della legge cit. è dunque confermata dal fatto che nel nostro ordinamento giuridico la protezione dell'ambiente, come ha messo in luce il giudice delle leggi, è da sempre imposta da precetti costituzionali (artt. 9 e 32) ed attiene ad un bene che assurge a valore primario ed assoluto. L'art. 18 cit., sebbene non retroattivo, oltre a sancire la già ricordata legittimazione all'esercizio dell'azione di tutela ambientale dello Stato nonché degli altri enti pubblici territoriali "sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo" e l'espressa attribuzione della competenza giurisdizionale al giudice ordinario (disposizione processuale di immediata applicazione: Cass. S.U. 12 febbraio 1988 n. 1491), ha definito e tipizzato l'illecito ambientale, richiedendo, quale suo elemento costitutivo, una condotta dolosa o colposa, violatrice "di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte".
Come è stato perspicuamente scritto in una precedente occasione da questa Suprema Corte (Cass. 19 giugno 1996 n. 5650), la configurabilità dell'ambiente come bene giuridico non trova la sua fonte genetica nella cit. legge del 1986 (che si occupa piuttosto della ripartizione della tutela tra Stato, enti territoriali e associazioni protezionistiche) ma direttamente nella Costituzione, considerata dinamicamente, come diritto vigente e vivente, attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni (artt. 2, 3, 9, 41 e 42) che concernono l'individuo e la collettività nel suo "habitat" economico, sociale, ambientale. Tali disposizioni primarie elevano l'ambiente ad interesse pubblico fondamentale, primario e assoluto, imponendo allo Stato un'adeguata predisposizione di mezzi di tutela, per le vie legali, amministrative e giudiziarie. Pertanto anche prima della legge cit. (ma di ciò la Corte d'appello non si è avveduta) la Costituzione e la norma generale dell'art. 2043 c.c. apprestavano all'ambiente (secondo le definizioni che ne sono state date nel corso dell'esame del secondo mezzo) una tutela organica e piena, di cui era già allora espressione la legittimazione attiva degli enti territoriali direttamente danneggiati, rappresentativi della collettività organizzata lesa in un suo bene primario ed assoluto.
L'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata non appare tuttavia rilevante e decisivo, posto che, al di là delle incongrue affermazioni di principio, essa si fonda su ragioni sufficienti a sorreggerla, pur nel differente ordine di idee fin qui esposto.
Invero la Corte d'appello ha rifiutato l'ammissione di un'ispezione e di una consulenza tecnica in ragione della loro "inutilità", subito dopo meglio chiarendo il suo pensiero con l'assumere, a giustificazione del rifiuto, "la genericità dei fatti dannosi allegati dall'appellante", la qual cosa avrebbe connotato la sollecitata indagine istruttoria come "puramente ed inammissibilmente esplorativa"; ciò dopo aver ricordato, a confutazione della tesi dell'ap-pellante, secondo cui "il danno ambientale assunto non doveva comunque essere provato, perché non contestato", che al contrario il Calò ebbe a contestare "fin dal primo atto difensivo che la propria attività estrattiva avesse procurato danni".
Risulta dal testo della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso che il Comune, in sostanza, denunciò, a fondamento della sua azione risarcitoria, "sic et simpliciter", un'attività estrattiva di ingenti dimensioni, di cui il convenuto eccepì sempre la piena legittimità, "perché autorizzata dal Corpo delle Miniere, Distretto Minerario di Napoli, e sempre praticata nel rispetto delle norme di legge e di tecnica"; senza che l'attore abbia mai, in contrario, addebitato al Calò una sola specifica violazione, che fosse sintomatica di una condotta dolosa o colposa, tale da far supporre un'attività non più pienamente lecita ma potenzialmente rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c. (l'unica norma disciplinante, all'epoca, la materia). Si è detto che vano è il richiamo a una presunta violazione dell'art. 6 del regolamento edilizio comunale, già disapplicato dal giudice penale; e può aggiungersi che, per conseguenza, è inconcludente invocare un'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori, se e in quanto, come sembra, emessa proprio in base all'illegittimo art. 6 del regolamento.
Quanto poi alle presunte violazioni, accennate a proposito del secondo mezzo, della legge 9 aprile 1959 n. 128 (norme di polizia delle miniere e delle cave), "concernenti le distanze dalle strade, dai corsi d'acqua, ecc., nonché la sicurezza per le persone che vi lavorano e per i terzi estranei", a parte ogni valutazione di pertinenza al tema, che non compete in questa sede, la Corte d'appello le ha implicitamente incluse nel suo complessivo e riferito giudizio di "genericità" delle deduzioni dell'attore, ne' il ricorrente oppone di averle invece, nel corso del giudizio di merito, più precisamente dettagliate, per renderle concrete e aderenti alla fattispecie.
Occorre ricordare che, in tema di danno ambientale, sia per i fatti anteriori alla legge del 1986, regolati dal solo art. 2043 c.c., sia per i fatti successivi, disciplinati dall'art. 18 cit., non è sufficiente la modificazione, alterazione o distruzione dell'ambiente naturale considerata da un mero punto di vista obiettivo, nella sua materialità, ma occorre l'elemento soggettivo intenzionale, che cioè la condotta sia "dolosa o colposa" e, per la legge speciale, qualificata dalla "violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge"; altrimenti vigendo la nota causa esimente dell'esercizio legittimo di un diritto ("qui suo jure utitur neminem laedit").
In questa situazione processuale, nella quale, stando agli accertamenti e alle valutazioni insindacabili del giudice di merito, nulla è stato provato se non il semplice dato obbiettivo della corrosione della collina per effetto dell'attività estrattiva, legittimo si palesa il rifiuto tanto dell'ispezione quanto di una consulenza tecnica, la quale ultima, in particolare (ma altrettanto dicasi della prima), come è giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, non può mai essere ammessa ed espletata per sopperire all'inerzia probatoria della parte e segnatamente non può avere finalità semplicemente esplorative, volte cioè a ricercare, in luogo della parte onerata, gli elementi fattuali da porre a sostegno delle pretese fatte valere nella causa.
Nè si obietti che il danno ambientale sia rilevabile solo col ricorso a determinate cognizioni tecniche, sicché, versando la parte nell'impossibilità di provarlo in altro modo, non possa il giudice, senza contraddirsi, respingere l'istanza di consulenza e nello stesso tempo ritenere non provato ciò che proprio essa avrebbe dovuto dimostrare.
Bisogna invero distinguere tra i fatti obiettivi, che la parte è in ogni caso nella concreta possibilità di provare, quale coordinate del danno, e che consistono nell'evento materiale in sè, corrispondente alla modificazione delle caratteristiche esteriori dell'ambiente, e nelle condotte dolose o colpose che l'hanno provocata; e la valutazione tecnica dell'evento ad opera di esperti, la quale può nei congrui casi rendersi necessaria, onde appurare se quella modificazione configuri un danno ambientale giuridicamente rilevante.
Peraltro gli enti territoriali titolari dell'azione risarcitoria dispongono di propri uffici tecnici idonei ad offrire al giudice la prova, o un principio di prova, dei presupposti obiettivi del particolare danno lamentato, ragion per cui può ben dirsi che, nella speciale materia in esame, la consulenza tecnica d'ufficio venga di regola ad assumere un peculiare ruolo integrativo, di verifica di precedenti accertamenti eseguiti "da qualificati organismi pubblici", solo in presenza dei quali, non sussistendo inottemperanza del danneggiato all'onere della prova, non può fondatamente rigettarsi la richiesta istruttoria, che si presenta in tal caso come lo strumento tecnicamente più funzionale ed efficace d'indagine (cfr. Cass. 1 settembre 1995 n. 9211 cit.). Censurabile, in conclusione, sotto il primo aspetto, la sentenza impugnata è viceversa ineccepibile nel resto, e inevitabile pertanto è il rigetto del ricorso.
Soccorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso a Roma, addì 7 maggio 1997.